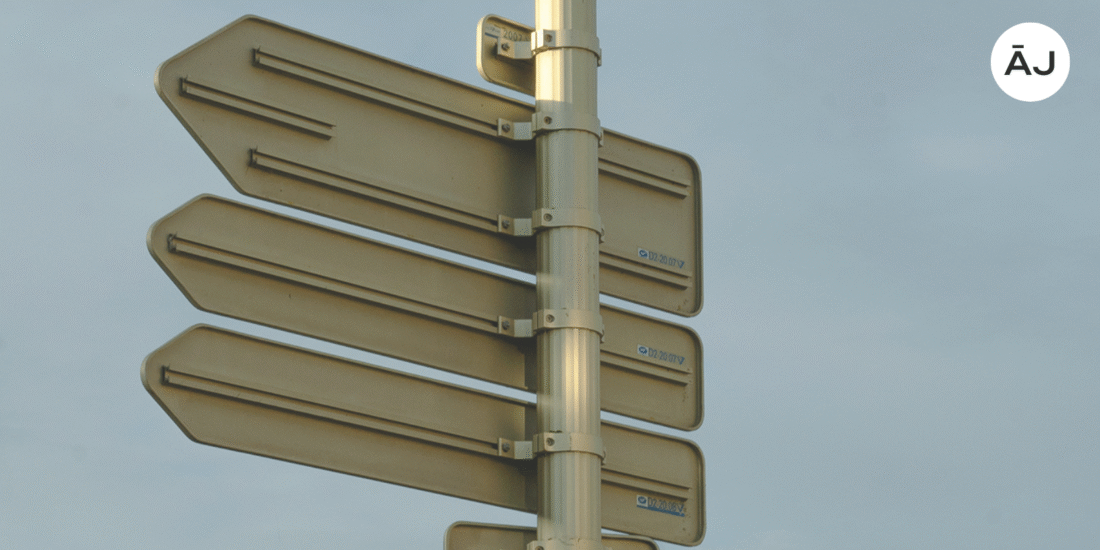Vi dirò una cosa, quando le assistenti sociali vi offrono di che non svenire, per graziosa elargizione, cosa che per loro è un’ossessione, avete un bel tentare la fuga. Vi inseguiranno fino ai confini della terra, con l’emetico in mano. Quelli dell’Esercito della Salvezza non sono da meno. No, contro il gesto caritatevole non c’è difesa, che io sappia. Si china il capo, si tendono le mani tutte tremanti e giunte e si dice grazie, grazie signora, grazie mia buona signora.
Samuel Beckett, Molloy
L’annosa questione: psicologia e status quo
Quest’estate nella mia bolla si è acceso un breve ma vivace dibattito: alcuni psicologi attivi su Instagram hanno reagito con indignazione alla pubblicazione di un libro scritto da una nota sociologa che – a quanto ho letto – accusava la psicologia e la cultura psicologica di contribuire al mantenimento dello status quo capitalista. Io non ho letto il libro, così come non lo avevano letto gli psicologi offesi, ma la tesi non è certo nuova né particolarmente controversa, se non per chi vive in determinati recinti disciplinari. Checché ne pensino i singoli professionisti, lo studio del ruolo e dell’influenza di psicologia e psichiatria nella società non si è esaurito con Foucault né con l’antipsichiatria, e il volume della sociologa rappresenta una pubblicazione tra molte. Certo, come per ogni discussione, c’è chi è d’accordo e chi no. Il tema, d’altronde, è complesso.
Dal mio personale punto di vista, è indubbio che la psicologia e il suo precipitato culturale abbiano un ruolo di rilievo nel mantenimento dello status quo, non tanto come forza autonoma di imposizione, quanto come dispositivo che raccoglie e riformula, attraverso le proprie categorie, le posture esistenziali rese necessarie dalle condizioni materiali del capitalismo. Più che rifletterne semplicemente le esigenze, essa ha contribuito a costruire una forma di vita compatibile con i suoi vincoli, trasformando imperativi di adattamento in criteri di salute mentale e in norme interiorizzate che individualizzano il malessere e ne oscurano la radice collettiva e materiale. D’altronde, sul piano epistemologico, la psicologia non si propone di interrogarsi su come possa configurarsi una ‘vita buona’, su quali forme sociali permettano realmente di fiorire: il suo compito è descrittivo e funzionale, non etico-politico. Si concentra sul funzionamento, sull’adattamento, sull’equilibrio interno dei soggetti rispetto al presente stato di cose. E questo, in sé, ha una sua positività: la psicologia si propone di alleviare la sofferenza nel qui e ora, non in un mondo possibile, ancora soltanto pensato, più giusto di quello attuale. Il modo in cui spiega e interpreta la sofferenza, tuttavia, finisce per tradurre le contraddizioni sociali in questioni psichiche e individuali, contribuendo a ciò che Mark Fisher (2009a) ha definito realismo capitalista: la percezione diffusa che non esista un’alternativa credibile all’ordine esistente. La funzione terapeutica della psicologia rende quel realismo non solo un paradigma economico o ideologico, ma anche un’esperienza affettiva e percettiva. È come se ne irrigidisse le maglie, consolidando la convinzione, ormai sedimentata nel senso comune, che non possa esistere una società diversa – e dunque nemmeno una psicologia diversa, né una cura che non coincida con l’adattamento al mondo così com’è.
La psicologia, insomma, viene intesa come una questione che riguarda il privato, la cura dei singoli individui. Lo si coglie bene, del resto, dalle reazioni di sbigottimento degli psicologi sopracitati quando hanno scoperto che la loro disciplina può essere sottoposta a scrutinio non soltanto per i suoi effetti individuali, ma anche per quelli sociali.
Ciò non significa, ovviamente, che la psicologia vada evitata o condannata. Non si tratta di giudicare gli usi e i benefici individuali, certamente importanti, ma di interrogare il riverbero collettivo di una disciplina sempre più presente nel discorso sociale. Poi, singolarmente, lo sappiamo: bisogna pur sopravvivere.
Uno degli autori che a mio avviso ha saputo descrivere con un tocco particolarmente incisivo e personale questa dimensione è stato proprio Fisher (2009b, 2014): la sua scrittura, nutrita da una profonda sofferenza esistenziale, ha mostrato come il dolore possa, nonostante tutto, aprire varchi di riflessione e significato politico all’interno delle costrizioni concettuali della psicologia e del realismo capitalista.
Vorrei, quindi, permettermi di dare per buono questo punto, rimandando a chi lo ha descritto prima e meglio di me – oltre a Fisher, consiglierei: Castel 2024, Smail 2005, Rose 2007, e ovviamente Foucault 1961, 2003 –, e riflettere qui sul rovescio del problema: se la psicologia è accusata di depoliticizzare, normalizzando e clinicizzando istanze che gioverebbero di una riflessione non medica, cosa succede quando cerca di entrare nel terreno del politico?
La questione non è né banale né inappropriata, dal momento che se critichiamo la mancanza di consapevolezza politica della psicologia, dobbiamo essere pronti a una psicologia che entri in campo e si ‘mischi’ con la politica. Rispetto al piano della pratica clinica, molti professionisti credono a questa via e promuovono approcci più consapevoli e responsabili dal punto di vista politico; si pensi, ad esempio, agli sviluppi più recenti della psicologia affermativa rispetto alla varianza di genere e agli orientamenti sessuo-affettivi. Con “psicologia affermativa” si intendono quei modelli clinici che mirano a riconoscere e valorizzare l’esperienza delle persone LGBTQIA+, spostando l’attenzione dalla correzione o normalizzazione delle differenze alla costruzione di contesti di vita in cui esse possano esprimersi liberamente (Singh & McKleroy 2011). In questo senso, la clinica assume una postura esplicitamente politica di sostegno e legittimazione.
Se la politicizzazione della clinica è un’impresa rischiosa, ma che vale la pena intraprendere, c’è tuttavia un altro modo in cui la psicologia entra nella politica, e che richiede ancora più attenzione: quando è la politica stessa a servirsi del linguaggio psicologico per formulare le proprie rivendicazioni, trasformando la clinica in una fonte di legittimazione e in un vocabolario per nominare l’oppressione. Il caso forse più noto in questo senso è stato l’uscita dell’omosessualità dal manuale diagnostico più utilizzato dai terapeuti, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) nel 1980 (definitiva nel 1987). Una decisione certamente sostenuta da studi scientifici, ma che seppe incidere in maniera determinante sul modo in cui la cultura percepiva l’omosessualità. Vi chiedo di tenere a mente questo esempio, perché ci tornerà utile in seguito.
Soffro dunque lotto
Il problema della psicologia – come della psichiatria, con cui condivide relazioni istituzionali ed epistemologiche profonde – è che tracima, sempre. Tracimando, si dissemina, diffondendosi nelle pratiche quotidiane, nei linguaggi, nei modi stessi di pensare. Mentre muta il lessico con cui parliamo del malessere e perfino di noi stessi, la psicologia gode di un’autorità epistemica sociale sempre più forte, unita a un certo potere veridittivo, cioè la capacità di produrre enunciati che vengono riconosciuti socialmente come veri. Potere che si rafforza proprio perché non sempre riusciamo a scorgerne le storture: d’altronde parliamo di una disciplina benintenzionata, una disciplina della cura. E proprio nella cura si annida il paradosso: forza che solleva e trattiene, promessa che apre e gesto che vincola, intreccio di gratitudine e di debito.
La tesi che vorrei avanzare qui è semplice ma so che creerà dispiacere: se la psicologia ha bisogno della politica, non è affatto detto che valga l’inverso. Quando il campo politico si affida a categorie e linguaggi psicologici, corre infatti il rischio di piegarsi a posture che non aprono nuove possibilità di trasformazione, ma le irrigidiscono, producendo un sollievo tanto immediato quanto illusorio e temporaneo.
In un saggio che si intitola significativamente Wounded Attachments (1993), la filosofa femminista Wendy Brown analizza una tensione interna a molte politiche dell’identità – in particolare a quelle femministe, antirazziste e queer sviluppatesi negli anni Ottanta e Novanta. Mostra come, nelle società contemporanee, le identità politiche emergano dentro un intreccio di capitalismo, liberalismo e poteri disciplinari, assumendo spesso la forma di un ‘attaccamento ferito’: una forma di legame che nasce dalla ferita storica e dalla condizione di subordinazione, ma che finisce per trarre da quella stessa ferita la propria coerenza e la propria forza. Invece di orientarsi verso la trasformazione dei rapporti di potere che l’hanno prodotta, l’identità tende così a investire nella propria ferita, a custodirla come fondamento di riconoscimento. È qui che si genera, per Brown, una tensione psico-politica: la sofferenza diventa non solo esperienza, ma categoria pubblica di legittimazione, un linguaggio terapeutico attraverso cui la domanda politica si articola come domanda di cura e di risarcimento. L’attaccamento alla ferita, l’investimento nel dolore, la ricerca di colpa e di compensazione si traducono in strategie politiche reattive, fondate su ciò che Brown, riprendendo Nietzsche, definisce ressentiment: quel risentimento che nasce dall’impotenza ad agire e che, invece di trasformarsi in forza creativa, si fissa nella colpa, nel giudizio morale e nel bisogno di riconoscimento da parte dell’altro (Brown 1993, 400–401). La psicologizzazione del conflitto si innesta così nella scena politica: gli attaccamenti feriti che danno forza all’identità rischiano di trasformare la politica in un linguaggio terapeutico, volto più a custodire e rappresentare la ferita che a mutare i rapporti di potere. In fondo, quello che Brown mette in luce è il rischio che il riconoscimento politico si fondi su una modalità reattiva e dipendente, ancorata alla necessità di un’autorità esterna per legittimare la propria rivendicazione. Per Brown, è l’autorità colpevolizzante del dolore e della ferita, ma oggi possiamo vedere come la psicologia possa inglobare questa funzione, conferendole l’autorità epistemica di una scienza sociale sempre più rilevante.
Con permesso
In questo affidarsi a un’istanza esterna per legittimare le rivendicazioni si coglie bene ciò che Brown diagnostica nell’età neoliberale inaugurata tra gli anni Ottanta e Novanta con l’affermarsi delle politiche di Reagan e Thatcher: la libertà scivola dalla sfera dell’autonomia a quella della licenza, cioè del permesso di fare, sempre revocabile perché dipendente da un’autorità che concede o nega (Brown 1995, 24–25). Nel suo lessico, il neoliberismo non è soltanto un sistema economico, ma un regime di soggettivazione che trasforma la libertà in una tecnica di governo: non più spazio di resistenza, ma forma di adesione. In questa cornice, l’individuo è chiamato a percepirsi libero proprio nella misura in cui si conforma alle norme e ai vincoli del mercato – gestendo se stesso come un’impresa, ottimizzando la propria vita come capitale umano (Brown 2015, 35). La libertà diventa così un meccanismo di interiorizzazione del potere: ciò che appare come scelta autonoma è in realtà il risultato di una delega ai criteri di efficienza e competitività che regolano il mondo sociale. Ridotta a licenza, la libertà perde la sua dimensione collettiva e trasformativa per farsi condizione concessiva, che non mette mai in questione i rapporti di potere da cui dipende. Al contrario, li ribadisce: se la mia libertà dipende dal poter fare, essa resta sempre soggetta a una condizione esterna che può essere ritirata o negata.
La psicologia si presenta, purtroppo, come un ottimo dispositivo per mettere in atto questa dinamica. Il suo impianto normativo stabilisce che cosa è sano e che cosa è patologico, che cosa è legittimo e che cosa no. Misura e soppesa le sofferenze, le traduce in una grammatica scientifica che porta con sé tutta l’autorità epistemica della scienza moderna. Dice chi può essere in un certo modo e fino a che punto, delimita i confini di ciò che è accettabile. E, se mi si può obiettare che è una disciplina eterogenea e non monolitica, che non vuole più assumere questo ruolo normativo, mi sento di dire che non c’è bisogno che lo faccia. Siamo noi stessi, spesso, a conferirle questo ruolo: non solo nelle nostre vite individuali – dove può avere senso, a seconda dei casi – ma anche nello spazio politico, dove diventa sempre più spesso lo strumento per legittimare rivendicazioni e riconoscimenti. Siamo noi stessi, per primi, a sperare che ci sia un’autorità buona che ci dia il permesso di essere, di fare e anche di lottare per certe istanze.
Ma torniamo all’esempio della rimozione dell’omosessualità dal DSM: abbiamo detto che fu un gesto politico, che oggi leggiamo come l’atto con cui una forma di vita, fino ad allora marchiata come patologica, veniva finalmente ammessa nei confini del ‘normale’. Questo passaggio esemplifica con chiarezza la logica concessiva che struttura politicamente la psicologia: una forma di vita viene riconosciuta come legittima solo dopo essere stata, in precedenza, delegittimata. Vale la pena soffermarsi sulla modalità attraverso cui ciò avviene: per sostenere che determinati orientamenti o identità debbano essere accettati, si ricorre spesso all’argomento biologico o genetico. L’assunto implicito è che, se non si tratta di una scelta, allora non vi è colpa, né divieto.
Questa postura ideologica – sospesa tra bioessenzialismo e fallacia naturalistica – non nasce certo all’interno della psicologia: si tratta di un dispositivo che il femminismo e gli studi postcoloniali cercano continuamente di smascherare e decostruire. Tuttavia, la psicologia contemporanea ne rappresenta oggi una delle principali sedi di riproduzione, e se in certi contesti possiamo affermare con decisione che la donna non si riduce all’utero e l’uomo non si riduce al cromosoma Y, altrove non esitiamo a legittimare orientamenti sessuali o identità di genere sulla base di presunte evidenze genetiche o neurobiologiche. Una logica contraddittoria che può talvolta avere valore tattico, ma che, assunta come orizzonte politico, consegna le vite alla richiesta minima che venga ritirato il veto sulla loro espressione, senza mai intervenire sulle condizioni materiali in cui il dolore prende forma.
Facciamo un altro esempio, più delicato. La psicologia ha fornito i dati per dimostrare che, in caso di stupro, molte persone entrano in uno stato di freezing, di immobilità – tonic immobility –, e che questa reazione, lungi dall’essere un difetto morale o una complicità, è una risposta neurofisiologica automatica (Möller et al. 2017; de la Torre Laso 2024). È stato importante, forse persino fondamentale, che queste evidenze venissero prodotte e riconosciute: hanno permesso di confutare l’accusa, tanto antica quanto infame, secondo cui chi non resiste non subisce davvero violenza. Ma proprio qui vorrei distinguere i piani. Sul piano strategico, l’uso dei dati psicologici può avere un’utilità concreta. Su un piano di analisi del potere, invece, ciò che quei dati hanno fatto è stato, in un certo senso, trasformare in concessione ciò che avrebbe dovuto essere un riconoscimento ovvio: la possibilità di non reagire fisicamente alla violenza senza per questo essere ritenute complici o consenzienti. E se questa conquista ha richiesto il timbro della psicologia, se è stato necessario attendere che degli studi producessero un contro-argomento che ci appare decisivo di fronte a un’obiezione che era illegittima in prima istanza, allora la nostra reazione non dovrebbe essere di gratitudine, ma di rabbia. Rabbia per gli spazi minuscoli entro i quali siamo costrette a muoverci, rabbia per l’idea che ci sia voluta una ricerca per concedere ciò che avrebbe dovuto essere riconosciuto da sempre. E rabbia, infine, pensando al sollievo che questi dati hanno dato alle vittime, che, negate culturalmente della possibilità di fidarsi di sé stesse, hanno dovuto attendere una convalida esterna per non sentirsi ‘sbagliate’ e per essere credute.
La psicologia, per come è strutturata, non può che collocarsi sul versante della licenza. Non può che fornirci questo tipo di aiuto, che non possiamo che accettare riluttanti. Può sostenere rivendicazioni strategiche – che vanno quindi attentamente monitorate – ma non riesce a produrre una libertà che sia al di fuori dello spazio autorizzativo e reattivo. Certo, questo non è un difetto della psicologia, né un’accusa al suo operato: in molti casi, come questo, il suo intervento è stato necessario. Ma proprio per questo occorre vigilare su come funziona questa utilità, su quali dispositivi di legittimazione si fonda e quali forme di dipendenza produce. Se vogliamo impiegare la psicologia in chiave politica, dobbiamo riconoscere che essa non può che operare entro il perimetro del permesso. Dobbiamo ricordarci che, fuori dal linguaggio del buon-vivere psicologico, nell’agire politico il permesso non va sempre chiesto – anzi.
Il rischio, il panico, il sollievo di pretendere
Occorre allora pensare una libertà che ecceda radicalmente questo impianto: non un sapere che legittima dall’alto, ma un agire che trasforma dal basso; non un permesso a essere, ma la costruzione di condizioni in cui l’essere non richiede alcuna autorizzazione. In questa prospettiva, la libertà si configura come pratica, e la pratica è pretesa. Se libertà significa sottrarsi alla logica del permesso, allora implica il rischio di concedersi da sé il diritto di esistere, di darselo insieme come collettività, di reclamare ciò che ci spetta. Pretendere non vuol dire sopraffare, ma assumere su di sé la forza e l’azzardo della richiesta: esporsi senza garanzie, senza l’appoggio di un sapere che certifica, sapendo che ogni pretesa può essere respinta, rifiutata, repressa.
È un esercizio instabile che Brown non a caso descrive come segnato da ansia e ambivalenza (Brown, 1995, 24), perché chi pretende si espone, rinuncia alla protezione di una legittimazione esterna, rischia: con le parole di Brown:
“Freedom of the kind that seeks to set the terms of social existence requires inventive and careful use of power rather than rebellion against authority; it is sober, exhausting, and without parents” (Brown 1995, 25).
Ma è proprio in questa esposizione che risiede la forza politica della libertà: non nel rivendicare a partire dalla ferita o dal dolore riconosciuto, ma nel riconoscere che nessuna libertà è innocente, che ogni atto di pretesa si muove dentro relazioni di potere e di responsabilità. La libertà, in questo senso, non è leggerezza né emancipazione pura, ma un impegno: la fatica di esercitare potere cercando di non riprodurlo nei suoi aspetti dannosi, di agire senza garanzie, di rispondere del mondo che si contribuisce a trasformare.
La pretesa, in questo senso, ha delle vicinanze con l’esercizio della parresia di cui parla Foucault (2009): dire la verità senza garanzie, assumendo il rischio che il potere reagisca, che la parola venga rifiutata o punita. Come la parresia, anche la pretesa non cerca legittimazione esterna, non si muove nello spazio sicuro del permesso, ma si giustifica nell’atto stesso in cui si esercita. Chi pretende, come chi parla attraverso la parresia, non invoca un’autorità che certifichi la verità o il diritto della propria posizione: si espone, mette in gioco se stesso, assume su di sé il rischio della propria forza. Ma se la parresia è innanzitutto un gesto individuale, la pretesa che qui ci interessa ha una dimensione collettiva e immaginativa: non si limita a dire la verità su ciò che siamo, ma reclama la possibilità di mondi nuovi, di forme di vita che ancora non hanno nome, e a cui vorrei che dessimo un nome insieme, come comunità. È una pratica che osa esigere oltre la ferita, nello spazio arioso del desiderio e della speranza, che apre spazi che nessuna licenza potrebbe mai concedere.
Forse mi viene in mente la parresia proprio perché mostra la sua differenza rispetto a un altro atto veritativo che Foucault aveva attribuito anche alla psicologia, quello della confessione. Confessarsi significa dire la verità di sé non per affermarla, ma per consegnarla a un altro che la raccoglie, la interpreta, la giudica; è un atto che non si esaurisce nel parlare, perché resta strutturalmente subordinato all’autorità di chi ascolta, sia essa il prete, il medico o lo psicologo (Foucault 1978).
La confessione è, dunque, una pratica che produce verità soltanto nella misura in cui viene riconosciuta da un’istanza superiore: non basta dire, bisogna che qualcuno convalidi. È in questo scarto che si gioca la differenza decisiva: nella psicologia ci confessiamo, nella politica pretendiamo. Per parafrasare un celebre manuale di auto-aiuto psicologico, nel politico ci troviamo a essere i figli adulti di una disciplina politicamente immatura. È difficile, è spaventoso, ma la buona notizia è che nel politico non siamo mai soli: possiamo darci il permesso insieme, legittimarci insieme, sostenerci nell’esercizio fragile e necessario della speranza e della pretesa.
Un piccolo inciso: il modo in cui la psicologia si politicizzerà, ovvero diventerà una disciplina più consapevole del proprio ruolo sociopolitico, avrà molto a che vedere con il modo in cui si pensa e si presenta al mondo come scienza: cioè con il modo in cui concepisce il proprio rapporto con il dato, con l’oggettività, e di conseguenza con quella pretesa di neutralità che, lungi dall’essere un presupposto innocuo, orienta in profondità la sua possibilità di agire nello spazio politico. Ma questo è tutto un altro articolo.
Fotografia di Chiara Alessandri
Bibliografia
Brown, W. 1993. Wounded Attachments, Political Theory, 21 (3), 390–410.
Brown, W. 1995. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton (NJ), Princeton University Press.
Brown, W. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York, Zone Books.
Castel, R. 2024. La gestione dei rischi. Dall’antipsichiatria al post-psicoanalisi. Mimesis, Milano.
De la Torre Laso, Jesús. 2024. “The Reality of Tonic Immobility in Victims of Sexual Violence: ‘I was Paralyzed, I Couldn’t Move’.” Trauma, Violence & Abuse 25 (2), 1630–1637.
Fisher, M. 2009a. Capitalist Realism: Is There No Alternative? Winchester: Zero Books.
Fisher, M. 2009b. The Privatization of Stress, Soundings, 42, 123–33.
Fisher, M. 2014, 19 marzo. Good for Nothing, The Occupied Times
https://theoccupiedtimes.org/?p=12841
Foucault, M. 1961. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Plon. Trad. it. Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 1976.
Foucault, M. 1978. La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano.
Foucault, M. 2003. Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973–1974). Paris, Seuil/Gallimard. Trad. it. Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973–1974), Feltrinelli, Milano, 2004.
Foucault, M. 2009. Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1983–1984), Feltrinelli, Milano.
Möller, A., Hans, P. S., Lotti, H. 2017. “Tonic Immobility during Sexual Assault – A Common Reaction Predicting Posttraumatic Stress Disorder and Severe Depression.” Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96 (8), 932–938.
Rose, N. 2007. The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton (NJ), Princeton University Press.
Singh, A. A., Vel McKleroy. 2011. “A Practice Framework for LGBT Affirmative Counseling and Psychotherapy.” The Counseling Psychologist, 39 (2), 167–210
https://doi.org/10.1177/0011000010366160 .
Smail, D. 2005. Power, Interest and Psychology: Elements of a Social Materialist Understanding of Distress. Ross-on-Wye, PCCS Books.