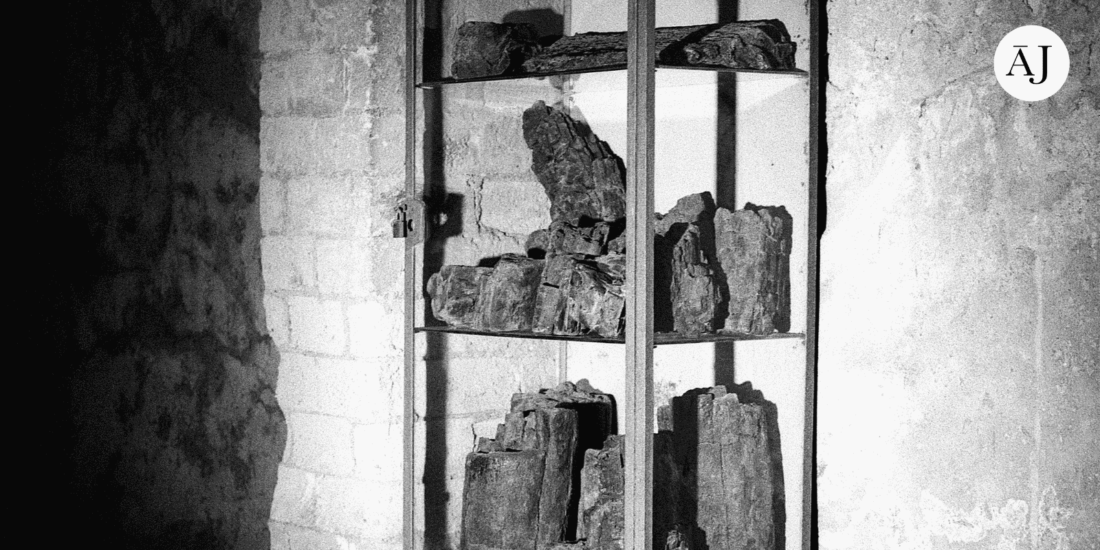Con “Daunia antica” o semplicemente “Daunia” si fa riferimento ad una regione storica, corrispondente alla parte settentrionale della Puglia. Quel territorio esteso e articolato nel quale è possibile distinguere cinque aree principali: il promontorio del Gargano; la pianura del Tavoliere, delimitata a nord e sud rispettivamente dal Fortone e dall’Ofanto; il tratto della laguna fra il Candelaro e l’Ofanto; il Subappennino e l’area ofantina, gravitante intorno a Canosa. In questa estesa area geografica proliferò la civiltà “daunia” — così legittimamente definita, in realtà, soltanto a partire dalla I età del Ferro (IX – VIII secolo a. C) fino al IV secolo a.C., come sottolinea una delle voci più autorevoli nel campo dell’archeologia classica e specificatamente italica, quella di Ettore M. De Juliis (1984, 137), — che sin dalle origini si distinse dalle altre due culture antiche della Puglia, pur essendogli affine, quella della Messapia e quella della Peucezia. Infatti, se tra Peucezia e Messapia è possibile riconoscere più tratti comuni perduranti nel corso del tempo, la Daunia, invece, con la sua posizione eccentrica e la sua perenne indisponibilità ai contatti con le culture allotrie, come quella greca — almeno fino al VI a. C (De Juliis 1988, 75–88) — , si caratterizza come un bacino culturale peculiare, indipendente, ben distinto nel panorama storico — archeologico italico e pugliese. Parliamo dunque di uno scrigno prezioso e caratterizzato da sfaccettature culturali davvero esclusive.
Non è dunque un caso che i Dauni furono una civiltà che per alcuni versi resta ancora oscura. La loro visione del mondo, espressa soprattutto attraverso sculture e decorazioni figurative complesse, si caratterizza per una difficile esegesi. Sia le sculture in pietra, le cosiddette “stele daunie”, con le loro ricche decorazioni, risalenti al VII — VI a.C, sia i bronzetti figurati, antropomorfi e zoomorfi, risalenti al Neolitico lo sono. Alcune statuine antropomorfe rivelano interessanti tratti culturali che possono aiutare a leggere alcune caratteristiche non solo della cultura daunia stessa, ma anche di reperti archeologici più recenti, come le stele daunie, appunto. Si potrebbe individuare un fil rouge che lega, nel corso dei secoli, la produzione artistica ritrovata nella regione settentrionale della Puglia che va dal Neolitico sino al VI a.C, almeno. Mi sembra possibile riconoscere, quindi, un sostrato culturale persistente — anche grazie alla ritrosia ai contatti della regione — nel corso dei secoli non tanto indoeuropeo, quanto indomediterraneo. È proprio sulla base degli studi effettuati su una civiltà poco indagata e conosciuta, risalente al quarto millennio a.C., quella indomediterranea, appunto, che vogliamo provare a leggere alcuni aspetti della cultura daunia.
Ma procediamo per gradi.
Comincerò col definire quali genti abitarono la Puglia e a partire da quando, cercando di individuarne anche l’origine attraverso le fonti storiche. Una volta tracciato un quadro generale delle civiltà antiche del territorio pugliese, porrò il focus sulla Daunia prendendo in considerazione innanzitutto i primi insediamenti del Neolitico per poi passare all’analisi di alcuni reperti archeologici riconducibili a periodi storici diversi: prima le statuette antropomorfe risalenti al Neolitico, poi le stele daunie di VII — VI a.C. Di questi ultimi monumenti mi soffermerò su un elemento in particolare, la grossa treccia posteriore rappresentata nelle stele di tipo femminile. Questa, infatti, costituisce il perno attorno al quale tirare le fila del discorso: incrociando dati archeologici e di linguistica storica, in virtù delle fonti archeologiche prese in considerazione — in particolare, le statuette antropomorfe -, avanzerò un’ipotesi interpretativa sul significato della treccia delle stele poiché il suo significato potrà, forse, illuminare e permettere di individuare il collegamento tra il sostrato culturale indomediterraneo, i reperti archeologici e la cultura daunia stessa. Ciò potrà permetterci, in definitiva, di riconoscere un’unità, una coerenza e persistenza culturale, o “unità di cultura”, come la ebbe a definire Vittore Pisani — nel suo saggio L’unità culturale indomediterranea anteriore all’avvento di Semiti e Indeuropei (1936, 199) -, che non avrà smesso di far sentire la sua forza nel corso dei secoli, “salvaguardata” in particolar modo dal carattere tradizionalista della Daunia.
Secondo la testimonianza dei maggiori storici antichi, come Erodoto ([440 a.C.] 1984, 170), Tucidide ([V sec. a.C.] 1996, 33) e Polibio ([146 a.C.] 2002, 87), tutti i popoli che abitavano la Puglia nel primo millennio a.C. — periodo dal quale si fa cominciare la storia dell’Italia antica, tra cui quella etrusca propriamente detta e quella romana (X — IX a.C) — erano definiti Iapigi, a loro volta suddivisi in tre grandi gruppi, i Peucezi, nell’area corrispondente grossomodo all’attuale Puglia centrale, i Messapi in Salento e i Dauni nella Puglia settentrionale. Ciò vuol dire che questi tre gruppi erano considerati parte della stessa cultura, e condividevano quindi anche l’origine. In passato, infatti, esistevano due tradizioni riguardo l’origine degli Iapigi: una, attestata per la prima volta in Erodoto, che a sua volta l’avrebbe appresa da Antioco di Siracusa (Erodoto 1984, 170), li riteneva di ascendenza ellenica, mentre la seconda, riportata in primis da Nicandro ([II secolo a.C.] 1903, 31), come indicato da De Juliis (1988, 9–15), li considerava di origine illirica. Dunque, stando alle testimonianze degli storici antichi e a ciò che gli studiosi moderni ritengono attualmente più probabile, verso la fine dell’età del Bronzo finale (XI – X secolo a.C), gli Iapigi sarebbero giunti in Puglia dalle sponde dell’Adriatico, per poi dare vita alle tre culture di cui sopra, unendosi a genti preesistenti e ad altri gruppi di provenienza egea. Allora è necessario chiedersi quale cultura abbiano incontrato gli Iapigi nella nostra regione sul finire dell’età del Bronzo (XI – X secolo a.C.). Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare i primi insediamenti del Neolitico, in particolare quelli della Puglia settentrionale.
I primi insediamenti della civiltà neolitica, localizzati lungo le coste del Tavoliere, risalenti a circa 2,7 milioni di anni fa, fanno pensare all’approdo di popolazioni provenienti dal Mediterraneo orientale. Non solo la tipologia di ceramica rinvenuta lì, ritenuta la più antica ceramica ritrovata nel Mediterraneo centro (Tinè e Simone 1984, 75–100) — occidentale, ma il fatto stesso di aver ritrovato numerosi insediamenti proprio lungo le coste ce lo fa credere: molto probabilmente i colonizzatori giunsero via mare e forse, come ritengono Tinè e Simone (1984, 75–100), con imbarcazioni capaci di trasportare esemplari di ovini, bovini domestici e vasi ricolmi di semi. Tutto ciò che probabilmente sapevano di non poter trovare nelle regioni in cui si accingevano a stabilirsi.
E ancora, proprio nella regione siro-anatolica, in località costiere come Mersin (Turchia), Ugarit (Siria), Byblos (Libano) e Hazorea (Palestina), sono stati ritrovati i prototipi delle più antiche ceramiche pugliesi impresse. Ma il fattore forse più dirimente in questo senso sta proprio nel nuovo modus vivendi dell’uomo del Neolitico: sappiamo che furono proprio le popolazioni delle regioni mediorientali — Iraq, Turchia, Palestina, Siria — le prime a raggiungere questa tappa fondamentale della storia dell’uomo e ad essere anche in notevole vantaggio temporale rispetto alle regioni dell’Occidente europeo al quale in seguito furono estese queste innovazioni. In particolare, la Puglia raggiunse questa importante tappa dello sviluppo umano con un considerevole ritardo: almeno due millenni dopo rispetto alle regioni mediorientali. Infatti, solo nel VI millennio a.C. si passò dalla fase in cui l’essere umano dipendeva per la propria sopravvivenza non più dalla natura, essendo cacciatore-raccoglitore, ma dal lavoro agricolo, dall’addomesticazione di piante e animali, conducendo sostanzialmente uno stile di vita sedentario. Infatti le datazioni ottenute con il metodo al carbonio radioattivo C14 per i primi stanziamenti agricoli nel Tavoliere risalgono al VI millennio a.C, e anche le ceramiche impresse più simili alle nostre contenute negli strati più profondi di Ugarit risalgono allo stesso periodo (Santo e Simone 1984, 75–100).
Ora, ponendo l’attenzione su uno dei più antichi insediamenti della cultura Neolitica del Tavoliere, quello nei pressi del lago Rendina, a sud dell’Ofanto, scopriamo come qui sono stati ritrovati, oltre a resti di solchi di capanne e varietà di ceramiche, i più antichi documenti riguardanti la sfera religiosa. Parliamo di straordinarie statuette antropomorfe che raffigurano molto probabilmente la Dea Madre o Grande Madre, una dea mediterranea da attribuire al sostrato culturale indomediterraneo di cui sopra, differente da quello indoeuropeo che è molto più di discusso e indagato. E, seppur abituati a sentir parlare di indoeuropei, in molti campi, da quello della linguistica storica, a quello letterario, a quello archeologico, è bene delineare, seppur brevemente, le loro caratteristiche principali così da poterne apprezzare le differenze rispetto a quello indomediterraneo, che è quello che in questa sede ci interessa.
Gli indoeuropei sono considerati il popolo che ipoteticamente ha costituito il bacino linguistico e culturale della civiltà Occidentale tutta, cioè quel popolo riconducibile a quel sistema linguistico alla base delle moderne lingue europee. Questi sarebbero originari, probabilmente, non dell’Europa, quanto meno, non “dell’Europa più marittima”, come scrive Fanciullo (2013, 215–218), ma delle grandi steppe dell’Eurasia, poiché pare non conoscessero il mare. Infatti, termini come “θάλασσα”, “mare” in greco e neogreco, presentano un’etimologia del tutto misteriosa e quindi non riconducibile al sostrato linguistico. Ne consegue che, se le lingue id est d’Europa non conservano tracce di una originaria denominazione comune del termine “mare”, allora vuol dire che gli indoeuropei, semplicemente, non conoscevano il mare. Perciò, grazie all’analisi di questo e di altri termini (Fanciullo 2013; Silvestri 1974; Pisani 1962), possiamo ritenere che le stesse genti indoeuropee — originarie di un luogo distante dal mare, cioè le steppe dell’Eurasia — abbiano trovato e intessuto relazioni, al loro arrivo in Europa, una popolazione sedentaria, quella indomediterranea, risalente al quarto millennio a.C. (Pisani 1936, 199–200; Silvestri 1974, 21–22) e che ne abbiano poi assorbito passivamente molti termini. Quegli stessi termini che hanno per noi una radice non a caso oscura e che a loro volta erano nuovi e necessari agli indoeuropei per indicare ciò che ancora non conoscevano — come termini propri di piante tipicamente mediterranee e del relativo clima (Fanciullo 2013, 215–221) — e che erano peculiari di quella cultura conquistata dalla quale, ovviamente, assorbirono poi anche aspetti culturali.
Se gli indoeuropei si caratterizzarono per una cultura di tipo patriarcale, monogama, con divinità celesti e credenze in una dimora ultraterrena per i morti e per l’utilizzo di un sistema numerico decimale, gli indomediterrranei, invece, utilizzavano un sistema matriarcale, praticavano la poliandria e una religione di tipo ctonio (Silvestri 1974, 31–37), credevano nella metempsicosi e utilizzavano un sistema numerico vigesimale; ma soprattutto praticavano il culto della Grande Madre (Silvestri 1974, 31–37). Fu Vittore Pisani, esimio glottologo, in un saggio del 1936, sulla base di indizi archeologici, ad individuare sullo scorcio del quarto millennio, una sostanziale unità di cultura nello spazio appunto indomediterraneo. A conclusione di questo saggio, il Pisani scrive:
“Nel quarto millennio a.C. una vasta zona di territorio, estendentesi dall’Egitto, attraverso la Palestina, l’Asia Minore, la Mesopotamia e la Persia meridionale, fino all’India settentrionale, e che aveva propaggini per tutto il Mediterraneo, si trova in possesso di una civiltà fiorente i cui centri più importanti si sono sviluppati, almeno per quel che oggi ci è dato sapere, attorno ai grandi fiumi Nilo, Tigri ed Eufrate, Indo” (Pisani 1938, 202–203).
Dunque parliamo di una cultura indigena autoctona, che “è stata rilevata, continuata e differenziata dai popoli sopravvenuti nei suoi territori, da Sumeri, Semiti e Indeuropei” (Pisani 1938, 200).
Le statuette antropomorfe ritrovate in uno dei più antichi stanziamenti neolitici più antichi del Tavoliere, nei pressi del Lago Rendina, pare rappresentino proprio la Grande Madre della cultura indomediterranea, con i caratteristici seni e la forma allargata del ventre. Un’origine mediorientale della “civiltà daunia” propriamente detta è altamente ipotizzabile anche sulla base di questi ritrovamenti archeologici. E se già le origini di questo popolo paiono essere caratterizzate da un sostrato culturale altro, diverso da quello indoeuropeo, le espressioni artistiche e culturali della Daunia successive alla fase neolitica, sembrano confermare la permanenza florida di questo sostrato culturale. Sostrato culturale che pare persistere ancora nella fase finale dell’età del Bronzo, periodo al quale risalgono le prime sculture in pietra della Daunia antica.
A Monte Saraceno, infatti, sono state recuperate molte sculture in pietra antropomorfe che rappresentano teste umane in uno stile rozzo ma estremamente efficace, come ritiene De Juliis (1988, 26). Teste in pietra che presentano i caratteri rudimentali del volto e non solo: sono rappresentate anche delle orecchie e degli orecchini ad anello. Già questi primi elementi ci fanno pensare a raffigurazioni di tipo femminile, e infatti la maggior parte delle teste ritrovate sono identificabili come femminili, soprattutto grazie all’elemento più caratteristico di questi ritrovamenti, che è quello su cui maggiormente mi soffermerò, e cioè la grossa treccia posteriore. È proprio la treccia ad aver permesso, infatti, il collegamento — seppur finora in soli due casi data la difficoltà di riconoscere i caratteri rudimentali della rappresentazione della treccia nei pilastri sui quali aderiva la testa — fra due teste a due busti parallelepipedi ritrovati nella vasta Necropoli di Monte Saraceno (De Juliis 1988, 25–26), uno iconico e l’altro aniconico.
Ma la tradizione della scultura in pietra della prima età del Ferro continua durante tutta l’età arcaica, dando vita alla fioritura delle “stele daunie”. Questi importanti monumenti dauni sono costituiti da una stele di calcare tenero locale, sottile e ampia, di forma rettangolare sormontata da una testa o giustapposta ad essa con un perno, o ricavata dalla lastra stessa. La stele era decorata con scene di vita quotidiana all’aperto — caccia, pesca, navigazione — o scene di vita domestica — molitura del grano e filatura. Inoltre di estremo interesse sono le rappresentazioni di miti spesso diversi da quelli della tradizione greca, o le immagini di riti magici-religiosi di tipo “erotico” o indicanti il culto dei morti e connesse a credenze di tipo escatologico, o ancora le rappresentazioni di figure mostruose. Queste ultime caratteristiche rimandano, ancora una volta, alla cultura indomediterranea. E in questo senso preziosi sono gli studi di Vittore Pisani (1938, 1941, 1962) e quelli di Domenico Silvestri (1974, 1977).
Tuttavia le stele non rappresentano solo soggetti femminili ma anche maschili, seppur in numero nettamente inferiore. Le due tipologie di stele si differenziano per alcune caratteristiche: quelle di tipo femminile presentano un incavo al centro delle spalle, nel quale si innesta il collo ornato di collane o pendagli e fibule sul petto. Inoltre, le spalle della stele di tipo femminile possono essere rappresentate fortemente rialzate. Le stele “maschili”, invece, si riconoscono per la presenza di armi, come spade o pugnali e per la presenza del pettorale o kardiophylax sulla parte anteriore della stele, mentre sul retro si trova spesso raffigurato lo scudo. Quelle maschili si caratterizzano anche per la mancanza dell’incavo centrale sul quale si sovrappone il collo inornato. Infine, anche la rappresentazione delle braccia è caratteristica dei due tipi. Le braccia “maschili” sono infatti rappresentate nude, prive di ornamenti, mentre quelle “femminili” si distinguono per la presenza di lunghi guanti.
Le stele di tipo femminile ritrovate sono in numero superiore rispetto a quelle maschili e questo fatto ha indotto l’archeologa Nava (1979, 136–137) ad ipotizzare — ipotesi al tempo rigettata dal De Juliis (1984, 137–184) — che le steli “femminili” rappresentassero individui uguali, e quindi tutta la comunità, ad esclusione degli individui maschili, invece, che sarebbero determinati in modo inequivocabile dalla rappresentazione delle armi. Ma su questa interpretazione, che riportiamo per rigore scientifico, non ci soffermeremo dato che anche nelle steli di tipo femminile sono presenti elementi che inequivocabilmente riconducono alla sfera femminile. In questa sede, invece, ci soffermeremo su quell’elemento particolare prima sottolineato: la grossa treccia che caratterizza le sculture in pietra, anche quelle precedenti alle cosiddette “stele daunie” del periodo arcaico.
Ritengo che le fonti da prendere in considerazione per comprendere qualcosa in più di questa grossa treccia rientrino nel campo di studi della linguistica storica. In particolare, voglio partire dall’analisi del lessico latino, andando a ritroso nel tempo attraverso alcuni termini, primo fra tutti “capillus”. In “Storia della lingua latina” (Pisani 1962, 126 — 127) notiamo come “capillus”, capello e anche pelo o capelli, chioma, sia dal linguista posto in relazione con il termine primitivo ario “kaparda”, che indicherebbe una treccia di capelli avvolta come una conchiglia. Il termine ario “kaparda” viene poi dallo stesso Pisani associato alla supposta forma sanscrita *kapeldo — */ *kapaldo dalla quale poi, forse, “capillus”. L’origine del termine latino che è, appunto, oscura rende questa ricostruzione del Pisani oltremodo interessantissima. Dirimente, poi, anche lo studio di Giulio Paulis del termine greco σκαπερδα, fune intrecciata: secondo la sua ricostruzione il greco σκαπερδα significherebbe anch’esso “fune intrecciata” (Σκαπέρδα 1969, 213–214) .
Dunque il latino “capillus” potrebbe affondare le sue radici in una delle più importanti isoglosse — ovvero una linea immaginaria tracciabile in un territorio nel quale si riconosce uno stesso fenomeno linguistico - indomediterranee prese in analisi anche da Silvestri (1974, 89–118) . Ciò pare avvalorato dal fatto che uno dei nomi di un dio notoriamente preario, Çiva, fosse proprio kapardi, derivato di kaparda e indicante ancora “capigliatura intrecciata”. Çiva, è bene sottolinearlo, era una divinità membro di una triade divina, la Trimūrti — associazione delle tre figure divine Brahma, Visnù e Çiva nelle religioni dell’Indo. Willbald Kirfel (1948), dimostra che le figurazioni occidentali della Trinità presentano non solo notevoli analogie con la Trimūrti, ma che queste abbiano le proprie radici nell’antica cultura indomediterrranea. Infatti, raffigurazioni della divinità compaiono già su alcuni sigilli della civiltà prearia — quindi preindoeuropea — dell’alto Indo per poi confluire nell’induismo, proprio attraverso la figura di Çiva.
Possiamo quindi, in conclusione di questo primo lavoro interpretativo, provare ad ipotizzare che per la civiltà sviluppatasi lungo tutto il Mediterraneo intrecciare i capelli fosse d’uso comune. Uso, dunque, probabilmente ereditato dalla stessa popolazione che abitò, fin dal Neolitico, l’antica Daunia e che rimase invalso almeno fino al VI a.C, secolo di grande produzione di stele daunie. Inoltre, potremmo anche cominciare a pensare che per gli indomediterranei questo uso fosse associato a divinità legate alla figura della Grande Madre. Ma, per corroborare ulteriormente questa tesi, sarà necessario analizzare ulteriori reperti archeologici e l’iconografia delle stesse stele daunie, che molto spesso costituisce l’unico veicolo di comprensione degli usi e dei costumi della società daunia e, a questo punto possiamo dirlo, spunto di comprensione ulteriore di quella che Pisani definisce “unità culturale Indomediterranea” (1938, 199–213). È importante, a parere di chi scrive, aggiungere che la difficoltà della ricostruzione linguistica, che permette di spostare la lancetta del tempo a periodi come il IV millennio a.C., non deve scoraggiare lo studio di una civiltà tanto antica come quella indomediterranea quanto piuttosto l’archiviazione semplicistica di interpretazioni superficiali e poco avvezze all’approfondimento. Forse solo con l’arditezza dello scavo delle fonti è possibile ottenere ipotesi sensate e foriere di ulteriori dubbi e possibilità.
Bibliografia
De Juliis Ettore. 1988. Gli Iapigi, Longanesi, Milano.
De Juliis Ettore. 1984. “L’età del ferro” in La daunia antica a cura di Mazzei Marina, Electa, Milano, 137 — 184.
Erodoto, a cura di A. Izzo D’Accinni. [440 a.C] 1984. Storie, vol III (Libri V- VII, 170), Rizzoli ed., Milano.
Fanciullo Franco. 2013. Introduzione alla linguistica storica, Il Mulino, Bologna.
Paulis Giulio. 1969. Σκαπέρδα, Paideia, 24, Brescia;
Mazzei Marina (a cura di). 1984. La Daunia antica: dalla preistoria all’altomedioevo, Electa, Milano.
Nava Maria Luisa. 2001. Le stele daunie, C. Grenzi, Foggia.
Nicandro da Colofone. a cura di Gina Servadio. [II sec. a.C.] 1903. Estratto di una Ricostruzione delle “Metamorfosi”, Ancona, Stabilimento a vapore F.lli Marchetti.
Pisani Vittore. 1938. “L’unità culturale indomediterranea anteriore all’avvento di Semiti e Indeuropei”, in Scritti in onore di Alfredo Trombetti, Milano, 199–213.
Pisani Vittore. 1941. “Dalle stelle alle stalle (due tracce della cultura mediterranea)” in Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa (Lettere, Storia e Filosofia”, Serie II, vol. 10, Milano.
Pisani Vittore. 1950. Recensione a “Die dreiköpfige Gottheit. Archäologisch-ethnologische Streifzüge durch die Ikonographie der Religionen” di Willibald Kirfel, Ferdinand Dümmlers Verlag, Bonn, 1948, Paideia, 5, 210–213.
Pisani Vittore. 1962. Storia della lingua latina, Rosenberg & Sellier, Torino;
Polibio, a cura di R. Nicolai. [146 a.C.]. 2002. Storie, X‑XXI, vol.3, Newton Compton Editori, Milano.
Silvestri Domenico. 1974. La nozione di indomediterraneo in linguistica storica, Macchiaroli, Napoli.
Silvestri Domenico. 1977. La teoria del sostrato: metodi e miraggi, Macchiaroli, Napoli.
S. Tinè, Simone Laura. 1984. “Il Neolitico” in La Daunia antica a cura di Marina Mazzei, 75–100, Electa, Milano.
Tucidide. trad. it. di F. Ferrari. V sec. a.C. 1996. La guerra del Peloponneso, vol. VII, Rizzoli, Milano.