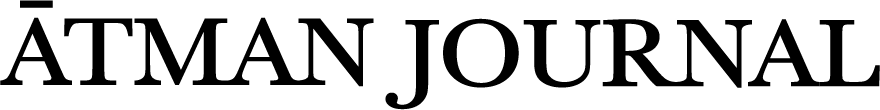“Ha perso la vita per un capello”, è così che il giornale iraniano Ham-Mihan dà la notizia in prima pagina della morte di Mahsa Amini, studentessa di 22 anni originaria di Saqqez, città che fa parte del Rojhilat, la regione del Kurdistan iraniano.
Il 14 settembre 2022, mentre si trovava a Teheran in visita ai parenti, Amini viene arrestata dalla polizia morale, che si occupa di far rispettare le leggi islamiche e il codice di vestiario imposto dal governo, con l’accusa di non indossare correttamente l’hijab, il velo divenuto obbligatorio nel 1979 per tutte le donne a partire dai nove anni. Dal 5 luglio 2022 una nuova direttiva ha reso più dure le conseguenze per chi ne fa un uso “inappropriato”.
Il 1979 è una data fondamentale per il paese, poiché è l’anno della rivoluzione che caccerà dal paese lo Shah Reza Pahlavi. La monarchia dei Pahlavi era di carattere autoritario, sostenuta all’interno del paese da una temuta polizia politica (Savak), mentre dall’esterno lo Shah poteva cintare sull’appoggio degli Stati Uniti. Negli anni di potere l’opposizione alla monarchia veniva repressa implacabilmente, e le ingerenze degli stati occidentali nelle risorse del paese, soprattutto per quanto riguarda il petrolio, erano sempre più forti. La famiglia reale e la corte ad essa legata erano diventate negli anni profondamente corrotte, a detta degli oppositori erano dei “venduti” ai poteri occidentali. Alla monarchia veniva criticata anche la profonda ineguaglianza economica che si era andata a creare all’interno del paese a causa delle loro politiche, che marginalizzava soprattutto le popolazioni non persiane, come i kurdi, gli arabi, i turkmeni, i baluci e i nomadi.
Dal momento in cui lo Shah fuggì dal paese, l’Iran si trasformò in una Repubblica Islamica, cambiando drasticamente la sua storia.
L’assetto istituzionale della Repubblica Islamica vede le sue origini negli insegnamenti dell’Ayatollah Khomeini, la guida suprema che ha ispirato la rivoluzione e che ha preso il potere dopo la fuga dello Shah.
Prima di diventare guida della nuova Repubblica, Khomeini è stato studente a Qom, il centro di sapere religioso del paese, dove nel 1936 divenne dottore in giurisprudenza islamica (mojtahed). Il mojtahed ricopre un ruolo chiave nell’islam sciita duodecimano, l’attuale religione di Stato dell’Iran, poiché viene considerato come colui che è in grado d’interpretare i fondamenti religiosi della fede a cui i credenti devono fare riferimento. Nei primi anni della sua carriera Khomeini ha mantenuto una posizione ambigua nei confronti dello Shah Reza Pahlavi. Se infatti da un lato lo criticava duramente, dall’altro non faceva mai riferimento alla sua caduta. A partire dagli anni 1960 le sue critiche si inaspriscono e diventa un avversario inflessibile. Per questo motivo finisce per essere espulso nel 1964 dall’Iran verso la Turchia, che lascerà per poi rifugiarsi in Iraq e infine in Francia, a Parigi, nel 1978.
Durante gli anni dell’esilio Khomeini ha iniziato ad imporsi progressivamente come leader dell’opposizione, e tramite delle audio-cassette che entravano illegalmente in Iran divulgando la sua voce e i suoi insegnamenti, ha iniziato ad influenzare una nuova generazione di giovani Imam e credenti che si opponevano allo Shah. I suoi discorsi erano semplici e diretti per riuscire a raggiungere anche le parti di popolazione più povere e meno istruite. Le sue critiche facevano riferimento sia alla sfera socio-economica, per quanto riguarda la povertà e le pessime condizioni di vita in cui si trovava parte della popolazione, sia a questioni di carattere internazionale, criticando aspramente gli Stati Uniti e Israele, considerati complici e burattinai del governo dello Shah, incolpando l’influenza occidentale del decadimento morale del paese.
Nonostante la figura di spicco dell’Ayatollah, non bisogna dimenticare che la rivoluzione scoppiata nel 1979 e che ha portato l’Iran ad essere lo stato-nazione che conosciamo oggi, era nata in origine come rivolta popolare che univa tante fazioni con un unico obiettivo: rovesciare la monarchia assoluta ormai corrotta dei Pahlavi e portare al potere la voce del popolo, che voleva scrivere un nuovo destino per il paese, rendendosi indipendente da ingerenze esterne. In questa folla in rivolta erano presenti vari gruppi, diversi movimenti e fazioni politiche, dai socialisti ai marxisti ai nazionalisti e religiosi.
Tra tutti questi attori alla fine è stato il fronte rivoluzionario raccolto intorno a Khomeini ad avere la meglio e così la rivoluzione di tutti si è trasformata in rivoluzione islamica. Quando nel 1979 lo Shah Reza Pahlavi è stato costretto a lasciare il paese, Khomeini è finalmente potuto tornare dall’esilio a cui era stato condannato per anni, ottenendo il ruolo di guida suprema a cui ambiva.
È stato lo stesso Khomeini ad invitare la umma islamica a unirsi per combattere contro il nemico comune, ossia l’Occidente, e la corruzione dilagante che ha portato nel paese. A partire da un testo scritto da Khomeini e diffuso clandestinamente in Iran nel 1973, viene esposta la necessità della costituzione di un governo islamico per l’Iran, affidandone la guida ai dottori della legge islamica. La rivoluzione di Khomeini vuole creare uno Stato in cui i cittadini sono allo stesso tempo fedeli, governati da una guida che deve essere scelta seguendo la dottrina del velayat‑e faqih: secondo cui la guida suprema corrisponde alla massima autorità in fatto di religione e legge islamica, che grazie alle proprie doti di sapienza abbia allo stesso tempo anche un ruolo di leadership politica per tutta la comunità.
Il nuovo governo ha progressivamente eliminato tutti i partiti e i movimenti non religiosi che avevano preso parte alla rivoluzione, dando inizio ad anni di terrore in cui si rischiava facilmente di essere arrestati e giustiziati se considerati nemici dello Stato.
In seguito a questi avvenimenti, nel dicembre 1979 viene adottata anche una nuova Costituzione, in cui viene specificato che il governo sarà rappresentato da una guida e dal consiglio dei guardiani della costituzione. L’articolo 109 della Costituzione indica che il capo dello Stato deve essere un mojtahed, virtuoso ed equo, che possa essere da esempio per tutta la popolazione, e che ha il compito di definire la politica generale dello Stato, e di arbitrare i rapporti tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Tra le altre cose, è anche capo dell’esercito e ha il potere di nominare i membri del consiglio di sorveglianza della costituzione, così come il capo del potere giudiziario e il direttore del sistema audiovisuale, che si occupa di decidere quali programmi trasmettere alla televisione e quali film far entrare nelle sale cinematografiche.
Tale sistema è diventato un nuovo metodo di controllo sulla popolazione, in cui i capi religiosi al governo dispongono dei massimi poteri, legiferando su qualsiasi aspetto della vita privata e pubblica dei cittadini. Il sistema politico messo in atto risponde in parte ad una volontà di strumentalizzare la religione per difendere l’identità nazionale di fronte alle aggressioni “imperialiste” e “occidentali”.
Parte di questo nuovo sistema di governo e la ripercussione della nuova Costituzione e dell’adozione della legge islamica passa in modo violento e sistematico sui corpi e sulle vite delle donne. Le restrizioni morali e religiose più severe colpiscono gravemente questa fetta della popolazione, che si trova improvvisamente costretta a comportarsi e vestirsi secondo rigorosi dettami religiosi. Le nuove leggi sono dense di discriminazioni a sfondo sessuale e hanno un impatto negativo sulle capacità di vivere vari aspetti della vita quotidiana.
Per portare un caso esemplare, secondo la Shari(legge islamica) la testimonianza di una donna in tribunale vale la metà di quella di un uomo; ciò significa che per legge una donna vale metà di un uomo, limitandone così l’accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso legali.
Le disuguaglianze e le discriminazioni riguardano anche il corpo e l’abbigliamento, imponendo alle donne sul territorio, iraniane e non, dei codici di comportamento e di vestiario ben precisi, mettendo in atto un controllo a 360 gradi. Stando all’articolo 638 del codice penale, “le donne che appaiono in pubblico senza gli abiti islamici prescritti (hejab-e-shar’i), verranno arrestate per un periodo tra i 10 giorni e 2 mesi, o costrette a pagare una multa tra i 50,000 e i 500,000 rial”. Secondo il cambio attuale, 1 rial corrisponde a 0,000022 euro. Il valore del rial iraniano è crollato drasticamente negli ultimi anni, accompagnato da un’alta inflazione e da un alto tasso di disoccupazione che hanno causato un ulteriore aumento dello scontento tra la popolazione.
Un altro cambiamento degradante riguarda l’abolizione del Codice della famiglia, in vigore negli anni di governo dello Shah, che assicurava un certo numero di diritti alle donne quali poter richiedere il divorzio, la limitazione della poligamia per i mariti e la possibilità di ottenere la custodia dei figli in caso di necessità.
Negli anni seguenti la rivoluzione, la messa in atto delle nuove leggi attraversa varie fasi. In un primo momento, l’imposizione dell’hijab non viene rispettata da tutti allo stesso modo.
L’antropologa franco-iraniana Fariba Adelkhah parla di “geografia dell’islamizzazione”, in quanto le nuove leggi hanno un impatto diverso rispetto ai luoghi in cui ci si trova a vivere, che sia in città o in campagna, in un quartiere centrale o periferico, che si lavori in un’amministrazione statale o in una compagnia privata. Così nei primi mesi dopo la rivoluzione poteva succedere che un’insegnante facesse lezione ad una classe di studentesse senza velo, o che una donna mettesse il velo sul luogo di lavoro e non all’esterno, o viceversa. Questa situazione è dovuta alle differenze di pensiero all’interno del paese, all’instabilità politica post rivoluzionaria e alla resistenza passiva della società civile urbana e delle donne ad una riforma messa in atto in modo autoritario. Nei primi mesi era anche difficile trovare delle sostituzioni di personale qualificato in determinati settori, a causa degli arresti di massa e delle persone che sono andate in esilio dopo la vittoria di Khomeini.
A partire dalla guerra in Iraq scoppiata nel 1980 e che sarà la causa della morte di migliaia di iracheni e iraniani, la missione militare e la mobilizzazione del paese hanno generato un aumento dei controlli tra la popolazione. Da questo momento, l’utilizzo dell’hijab viene richiesto anche in onore del sangue versato dai martiri per la nazione, e per il rispetto delle loro famiglie. Come conseguenza di queste leggi, le donne non vengono escluse dalla vita pubblica ma, nel rispetto delle nuove norme, vengono incoraggiate a partecipare attivamente alla trasformazione di questo nuovo modello di società. In molti casi sono le donne stesse a diventare le guardiane di queste restrizioni, e a fermare per strada le loro sorelle che non sono vestite in modo conforme, collaborando con i guardiani della rivoluzione.
Prima di diventare una costrizione, l’hijab veniva considerato dalle donne islamiche come un valore sociale, una scelta personale e religiosa che le distingue dal resto della popolazione. Allo stesso tempo, per le donne credenti, il fatto di imporre l’uso del velo a tutte le donne, anche le non credenti, è una banalizzazione di un simbolo sacro per l’Islam. Una parte di esse, infatti, pensa che non possa diventare un obbligo, ma che dovrebbe dipendere esclusivamente da una convinzione reale e da una scelta personale di fede. Allo stesso tempo, parte della popolazione sostiene senza indugi le azioni del governo.
Culturalmente il velo rimarca anche la separazione tra lo spazio privato e quello pubblico, il luogo in cui la donna è al sicuro e può mostrarsi e il luogo in cui la sua figura deve rimanere più nascosta per non creare squilibri e non metterla in pericolo. Per esempio, sul luogo di lavoro l’hijab viene visto anche come un modo per aumentare la produttività di uomini e donne che lavorano nello stesso ambiente: senza mostrare le proprie forme e la propria bellezza, l’aspetto della donna non rischia di rallentare i ritmi di lavoro dell’uomo e turbare questa collaborazione.
A supporto di coloro che difendono il diritto di poter scegliere o meno di mettere il velo e vestirsi secondo la legge islamica, nel Corano l’hijab non viene nominato se non tre volte: se ne parla soprattutto in termini di decenza e modestia nell’interazione tra i due sessi. Le stesse femministe islamiche rivendicano i propri diritti basandosi sul fatto che il Corano non è un testo discriminatorio rispetto al genere femminile, ma che il deterioramento della condizione della donna nella società islamica viene piuttosto da un retaggio culturale che si è evoluto nel tempo, elemento che non ha a che fare con il testo sacro della loro religione.
A questo proposito, Fariba Adelkhah rimarca una critica allo spettatore occidentale, che spesso si fa paladino dell’emancipazione della donna condannando l’uso del velo come oppressione alla sua libertà personale: il velo è una scelta e come tale va rispettata. Le donne che lo indossano non sono meno emancipate di quelle che non lo usano. Saranno piuttosto più consapevoli della loro scelta se viene lasciata a loro la possibilità di farlo liberamente.
Le donne iraniane, nonostante il regime di controllo e l’obbligo di coprirsi il capo, in determinate situazioni decidono di indossarlo a proprio piacimento. Non è un caso girare per le strade delle città iraniane e vedere donne che indossano un chador nero affianco a donne con un leggero hijab che lascia intravedere i capelli.
Mentre l’hijab, indumento obbligatorio, è un velo che copre solo il capo, lasciando scoperto viso e spalle, il chador è un indumento islamico tipico dell’Iran che viene indossato facoltativamente dalle donne più credenti o in particolari contesti. Consiste in un lungo mantello che copre interamente il corpo della donna, lasciando scoperto solo il viso. Generalmente è di colore nero ma esiste anche in altri varianti, e spesso viene indossato insieme ad un altro velo poggiato su testa e spalle in modo da inquadrare il volto.
La violenza delle politiche della Repubblica Islamica sui codici di vestiario consiste proprio nel fatto che la possibilità di scegliere individualmente non viene concessa e un utilizzo non consono dell’hijab può portare a conseguenze molto gravi.
È ciò che è successo nel caso di Mahsa Amini che, il 16 settembre, tre giorni dopo l’arresto per conto della polizia morale, muore nell’ospedale Kasra di Teheran. Il governo e la polizia giustificano il decesso per un attacco al cuore, incolpando la salute cagionevole della detenuta.
Le ragioni del decesso sono state contestate fin da subito e il governo ha tardato a dare ulteriori spiegazioni sul caso.
Alcune immagini del corpo della ragazza, scattate in ospedale e rese poi pubbliche, rendono difficile credere alla versione ufficiale di una morte naturale. Il padre smentisce la notizia dichiarando che la figlia godeva di ottima salute e che non ha mai sofferto di disturbi cardiaci.
Secondo fonti non governative, la morte viene ricondotta alle torture e alle violenze subite nei giorni di carcere, in particolare a dei colpi ricevuti sul cranio che hanno generato una frattura, visibile dai referti medici, che l’avrebbero portata al coma e poi alla morte.
Non è la prima volta che un episodio simile ha luogo nel paese. La polizia morale e il regime di repressione hanno causato numerose morti negli anni e secondo i dati di diverse organizzazioni per i diritti umani l’Iran risulta come uno dei paesi con più esecuzioni e condanne a morte al mondo, secondo solo alla Cina. La sezione iraniana di Human Rights Watch denuncia che dal 2010 ad oggi sono state eseguite 6894 esecuzioni, aumentate in particolar modo a partire dal 2021.
A poche ore dalla notizia della morte di Masha Amini iniziano le proteste, prima davanti all’ospedale dove era stata ricoverata, poi durante i funerali nella città natale di Saqqez, per poi dilagare nella regione del Kurdistan e in tutto il paese.
Non è la prima volta che in Iran prende piede un movimento di protesta così forte. Nel 2019 c’era stato un sollevamento popolare in tutta la nazione a causa di un aumento dei prezzi del carburante, che aveva poi finito per diventare una rivolta in cui si chiedeva il rovesciamento del governo e della guida in carica Ali Khamenei. Le proteste, iniziate pacificamente, sono state poi ricordate con il nome di Bloody November. Per rispondere alle mobilitazioni, il governo ha tagliato la rete internet in tutto il paese, causando un blackout generale durato sei giorni, durante i quali, secondo i report di alcune associazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, i protestanti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco sparati da cecchini posizionati su tetti ed elicotteri, oltre che da mitragliatrici. Alla fine delle rivolte i protestanti rimasti uccisi in quei sei giorni sono stati circa 1500, secondo alcune fonti addirittura 3000.
Il 15 novembre 2022, tre anni dopo l’accaduto, gli iraniani sono ancora in rivolta, e hanno commemorato l’anniversario del Bloody November continuando le proteste contro il governo per la morte di Mahsa Amini. Anche questa volta la polizia non si è risparmiata, contando che dall’inizio delle rivolte sono state uccise 451 persone, di cui 51 bambini, e circa 18,000 arrestate. La differenza è che questa volta il movimento resta costante, le persone non vogliono arrendersi. La morte di Mahsa Amini riguarda tutti, ma è diventata in particolar modo una lotta femminista e studentesca. Le università sono diventate luoghi di resistenza, in particolare la Sharif University di Tehran. In ottobre gli studenti che si trovavano all’interno sono stati bloccati dalle forze di sicurezza, e la popolazione si è riversata verso il campus per sostenere gli studenti intrappolati, chiedendone il rilascio e gridando “morte al dittatore”. Dai video pubblicati vengono mostrati gli studenti che scappano mentre la polizia spara su di loro colpi di arma da fuoco. Le proteste hanno raggiunto anche la prigione di Evin a Teheran, dove sono detenuti numerosi prigionieri politici. La prigione, che è stata denunciata varie volte per gravi violazioni dei diritti umani, ha preso fuoco nella notte del 15 ottobre, causando otto morti e una sessantina di feriti.
Nonostante il governo abbia cercato ancora una volta di isolare il paese tagliando la rete internet, le immagini e le notizie di ciò che sta accadendo hanno raggiunto ogni parte del mondo: donne in strada senza velo che salgono sulle macchine per dare fuoco agli hijab che non vogliono essere costrette a indossare, altre che a testa scoperta si tagliano ciocche di capelli e le mostrano orgogliose alle fotocamere. Le donne iraniane riprendono il proprio potere, occupano le strade, scintillano come il fuoco degli hijab che tengono tra le mani.
“Zan, Zandegi, Azadi”, donna, vita, libertà. Questa frase è diventata un simbolo delle rivolte, e vede la sua origine nello slogan delle donne libere curde, che nella lingua originale sarebbe “Jin, Jian, Azadi”. Nasce dalla Jineolojì, la scienza delle donne: l’insieme di teorie e pratiche del movimento delle donne del Kurdistan, che oltre a lottare per la liberazione e l’autodeterminazione del proprio popolo, porta avanti una ferma volontà di rottura radicale con il sistema di Stato-nazione patriarcale, capitalista e coloniale. Aso Khomeini, attivista di questo movimento, ne parla in un’intervista per l’espresso con Maria Edgarda Marcucci, che nel 2017 si è unita alle Ypj, l’unità di protezione delle donne, per sostenere la lotta curda e il progetto politico del confederalismo democratico del Rojava (Kurdistan siriano), e per la quale è stata condannata in Italia a due anni di sorveglianza speciale. Come Mahsa Amini, Aso Khomeini è originaria del Kurdistan Iraniano e nonostante viva da anni a Londra, continua le sue attività con il Kjar, la comunità delle donne libere del Rojhelat. Aso Khomeini ci ricorda che le donne dell’Iran e del Rojhelat sono sottoposte da anni a trattamenti disumani e degradanti, tra cui femminicidi, mancanza di istruzione e mancanza di diritti di base. L’applicazione della Shariha marginalizzato la posizione e il ruolo delle donne nella società, soffocandone le identità individuali e collettive.
«Non è stata solo la morte di un’altra donna; è stata il simbolo della morte delle donne e dei giovani in Iran», dichiara Aso Khomeini.
Attraverso questa rivolta stanno mostrando a tutti la loro resistenza, generando proteste in tutto il mondo. È stato creato un movimento internazionale molto ampio che organizza manifestazioni in solidarietà con il popolo iraniano, soprattutto grazie alla mobilitazione della comunità iraniana internazionale. Secondo Mahmood Amiry-Moghaddam, cofondatore e portavoce dell’organizzazione Iran Human Rights, le proteste svolte all’estero possono svolgere un ruolo fondamentale nel formare l’opinione pubblica in merito a ciò che sta succedendo in Iran, facendo in modo che anche i governi esteri sostengano il popolo iraniano. Amiry-Moghaddam ha dichiarato che la repressione dei manifestanti da parte del governo iraniano rappresentano gravi crimini contro l’umanità, e la comunità internazionale ha il dovere di condannare e investigare tali violenze impedendo che ne vengano commesse altre.
A partire da novembre ci sono state le prime sentenze di condanne a morte per alcuni manifestanti, con l’accusa di due crimini capitali: mofsed-e-filarz (corruzione) e moharebeh (guerra contro Dio e contro lo Stato). Secondo Iran Human Rights sono almeno 20 le persone condannate. Considerando che il governo iraniano ha già utilizzato la pena di morte per generare paura all’interno della società, si teme la messa in atto di esecuzioni approssimative senza preavviso. Per impedire che questo avvenga, la comunità internazionale non deve ignorare ciò che sta succedendo, ma continuare a criticare il regime e a chiedere che venga fatta luce sulle violenze e le violazioni dei diritti umani che sta commettendo, senza abbandonare le donne e gli uomini che stanno lottando contro un governo assassino.
Le proteste vanno avanti ormai da tre mesi, e ancora è difficile immaginare a cosa porterà di concreto questa mobilitazione. Un’effettiva caduta del governo significherebbe trovare un nuovo assetto politico per il paese, ma questa rivolta è popolare e spontanea, non ha partiti politici o figure di spicco alle spalle che possano prendere il potere una volta rovesciato il regime. Resta il fatto che questi mesi hanno segnato la storia del paese, ne stanno scrivendo un capitolo importante. Nei suoi discorsi ufficiali, Ali Khamenei continua a minacciare i manifestanti dicendo che il governo non ha ancora messo in atto tutte le sue forze, e che se volesse potrebbe mettere fine alla rivolta in qualsiasi momento. La realtà sembra essere ben diversa, e pur avendo messo in atto misure di forza e di violenza, questa volta le forze di sicurezza non sono riuscite ad arginare la marea di rabbia e insofferenza dei manifestanti.
Sembra che questa volta, al grido di “Zan, Zandegi, Azadi”, per tutte le donne, i giovani e gli uomini oppressi dal regime, la società iraniana sia disposta ad un prezzo molto alto pur di non retrocedere sulle proprie richieste.