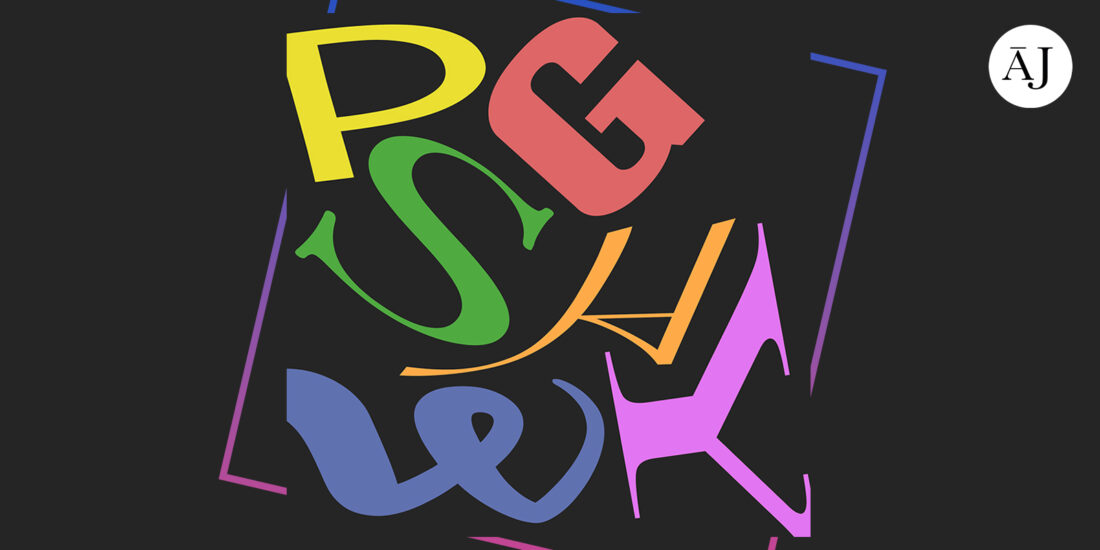Prima di cominciare a indagare sul colore delle parole, sarà utile concordare quali parole usare per indicare spesso controversi colori e fare un piccolo inventario di quel che si nasconde invece dietro tante parole apparentemente incolori. I colori dell’arcobaleno sono sei. Giallo, rosso e blu i fondamentali; arancione, verde e violetto i complementari. Più l’indaco, colore pretestuoso, che serve solo a fare sette, numero perfetto. In realtà, il vero settimo colore dell’arcobaleno dovrebbe essere il bianco, il colore della luce che li contiene tutti.
Cominciamo con il blu o azzurro, colore del cielo, che è anche il colore dei lapislazzuli, una parola che viene dal persiano. Si distingue dal celeste che è più chiaro e dal turchino che è più scuro. Celeste prende il nome dal cielo, cerulo e ceruleo sono suoi sinonimi. Ma c’è anche il cilestro e il mavì, di origine turca. E il letterario cesio, non quello radioattivo. Il turchino è un azzurro scuro e viene dal turchese, pietra turca. Un suo sinonimo è il blu comune, dal provenzale blau, che in italiano antico diede biavo e biado: azzurri chiari. Di qui viene sbiadire e sbiadito, all’inizio detto d’un azzurro impallidito. Il bluastro invece tende al blu e viene dallo pseudo francese bluette, tratto dalla parola francese per fiordaliso: bluet. Ma l’azzurro non è finito qui. D’Annunzio scrive: “Una bella mattina d’ottobre, piena di cobalto e di sole”. Il cobalto è l’azzurro intenso e viene dal tedesco Kobalt, tratto da Kobold, folletto, perché i minatori pensavano che un dispettoso folletto facesse loro trovare cobalto al posto del prezioso argento che cercavano. Un azzurro non ben definito è il glauco, celeste con sfumature verdi o grigie. Glauco figlio di Poseidone, da pescatore divenne creatura marina mangiando un’erba miracolosa e forse questo è il colore delle sue squame. Il blu è il colore della spiritualità, della trascendenza e delle forze celesti. Per i mongoli, Gengis Khan era figlio di una cerva e di un lupo blu. Gesù Cristo, come la Vergine, porta un mantello blu. Ma in Cina il blu è un colore mal visto. Anticamente, in cinese non c’era una parola per dirlo. L’ideogramma Ch’ing corrispondeva a tutti i colori dal grigio scuro al verde. Ma senza il blu. In Cina i fiori, gli occhi blu e i tessuti o i nastri rigati di blu portano sfortuna. In Europa centrale il blu è simbolo di fedeltà.
Ma passiamo al verde, definito come colore dell’erba fresca. Scopriamo subito che il verde può essere anche un colore del vino. Verdicchio delle Marche, Verdiso del Trevigiano, Verdèa del Piacentino. Per non parlare del Vinho verde portoghese. La verdesca è un tipo di squalo, il verdello o verdone è un uccello, ma verdone è anche un fungo chiamato anche colombina verde. Col verde quindi uccelli e funghi si confondono. I verdelli sono i limoni che maturano fra maggio e agosto e il verzellino è un passeraceo.
Il verde è il colore della speranza, dell’effimero, della fortuna, della precarietà delle cose. Per l’Islam è il colore del paradiso. In Cina è associato al legno che esce a primavera dalla terra nera. Talvolta il Diavolo appare di colore verde, un resto delle antiche divinità della vegetazione. Anche la croce di Cristo è talvolta raffigurata in verde, come il Graal e lo smeraldo, pietra ambigua. L’Apocalisse è dominata dal colore verde. Il trono del giudice della fine del mondo è “circondato da un arcobaleno dall’aspetto di smeraldo”. Per gli Aztechi il verde è associato alla fertilità e all’uccello Quetzal, dalle piume verdi. In alchimia il verde è “l’acqua regia”, il vetriolo, che si produce appena dopo la nigrido, fase iniziale del processo alchemico.
Il giallo viene dal latino galbinus, che era un verde-giallo. È un colore di varie tonalità. C’è per esempio il biondo che è un giallo non molto acceso. Flavo è il biondo poetico, dal latino Flavus. Invece fulvo è il biondo tendente al rossastro, dal latino Fulvus. Il giallo è il colore dell’invidia e della gelosia. È il colore di Giuda, della stella che i nazisti obbligavano gli ebrei a portare cucita addosso, dei crumiri e dei traditori. In Francia si dipingevano di giallo le imposte di chi tradiva la patria. I francesi dicono rire jaune per “riso amaro”, giallo è oltralpe anche il colore del marito cornuto, ma la maglia gialla è l’ambìto trofeo del Tour de France. Nel Medioevo il giallo e il verde erano i colori di cui venivano vestiti i pazzi. In alchimia, la cinitrititas era la prima fase di transizione della materia dalla nigredo verso la rubedo. Verde e giallo prestano la tinta alla bile, all’invidia, alla paura e alla malattia. In Cina il giallo è il colore riservato alle vesti dell’imperatore. È il colore della terra, ma anche del sacro Fiume Giallo.
Viene poi il rosso, che invece è il colore della forza e della salute. Robbio e Roggio sono sue forme antiche. Rovente significa strettamente rosseggiante. Anche la quercia detta rovere, la quercia rossa, (in latino robur-roboris) ha creato parole che hanno travalicato il campo del colore per passare a quello della forza: robusto, corroborare. La terra rossa usata per scrivere i titoli dei capitoli era la terra rubrica ed è così che si è arrivati alla rubrica telefonica. Rosso era il colore di cui l’uomo di Neanderthal spalmava i suoi morti, quasi per restituire loro il colore del sangue. Rosso è il colore di Marte e del dio egiziano Seth. Ma gli egiziani dipingevano di rosso quel che detestavano. In Messico si usava il rosso solo per sangue, sole e fuoco. Per i Maya era simbolo dell’oriente. In Cina rosso è Yang e nero è Ying. Il rosso Yang è simbolo di potenza sessuale, di gioia e di immortalità. Da noi il rosso è il colore della passione ma vestito di rosso è anche il cardinale che si vota alla chiesa. Rossa era Babilonia nelle parole dell’Apocalisse: “Babilonia, la grande prostituta, madre delle cortigiane e di tutti i vizi terrestri è vestita di porpora e di scarlatto e cavalca un mostro a sette teste, una creatura scarlatta e viziosa”. Maddalena, la peccatrice, ha i capelli rossi e i romani volevano che le prostitute indossassero parrucche rosse. Rosse erano le lanterne che indicavano le case chiuse. A luci rosse sono oggi i film pornografici. In alchimia il rosso, la rubedo è la fase finale della transmutazione della materia.
Il bianco è il colore che non c’è. Per gli Aztechi, bianco era il colore dell’occidente, dove tutto muore. Bianco è il colore dell’innocenza ma anche della morte. Lo Spirito Santo è rappresentato sotto forma di colomba bianca. In Cina il bianco è il colore della vecchiaia, dell’occidente e del male. Ma è anche il colore del lutto, nel senso di mancanza di colori. In alchimia, l’albedo è la fase intermedia fra la nigredo e la rubedo.
Il bianco viene dal germanico blank. Perché il bianco dei latini era albus. Ma anche quando si parla di bianco si finisce inevitabilmente nel vino. Albana di Romagna e Albarola della Riviera del Levante. Anche albero vuol dire bianco: era il nome del pioppo bianco. Albedine o albedo è la parte interna della buccia dell’arancia. Albàsia è antica voce per bonaccia, derivato da alba, cioè vento che si leva all’alba. Così albagia: boria, alterigia. Albo era una tavola bianca su cui a Roma si scrivevano i nomi dei magistrati, le feste solenni, le leggi. Oggi c’è quello dei giornalisti o quello delle figurine. Per non parlare di albume, albumina. Ma scialbo era anticamente lo strato di calce e intonaco con cui si coprivano gli affreschi. Scialbo è oggi quel che è sbiadito e morto.
Il nero è il colore dell’infinito e dell’assoluto. In psicanalisi è il simbolo del più profondo inconscio. Ma è anche il colore dell’inferno, delle messe nere, è la negazione della vanità e del lusso nelle toghe dei sacerdoti. Nera è la malinconia, in greco letteralmente “umore nero”. Misterioso è il culto delle Madonne nere – Czestochovwa, Tarragona, Chartres, Guadalupa. Sembra sia da ricondurre a divinità femminili del neolitico, che vivevano nel ventre della terra e che quindi erano simbolo di fertilità. Nera è la pietra della Mecca e la dea indiana Kali, mangiatrice della morte. Sarah-la-Kali, è la protettrice degli zingari che ogni anno vanno in pellegrinaggio alle Saintes-Maries-de-la-Mer per adorarla assieme alle altre: Maria Giacobea, Maria Salomé e Maria Maddalena.
Non abbiamo certo esaurito l’arcobaleno e già vediamo che colori e parole fortemente si compenetrano, si contagiano. Ma proviamo ora ad affrontare la questione da un altro punto di vista.
I colori e le parole fortemente si compenetrano, si contagiano. Da un punto di vista scientifico, il colore è luce, è un’onda. Più precisamente, il colore è quella parte di luce che un oggetto non assorbe. In altri termini, quel che resta della luce. Il colore delle parole dovrebbe quindi essere quel che resta delle cose una volta nominate. Nulla. Il silenzio. Le parole sono forse bianche, incolori? Ogni colore ha una diversa frequenza e si misura in nanometri. Ma l’occhio umano vede solo i colori che si trovano fra i 400 e i 700 nanometri. Vi sono dunque colori per noi invisibili. Allo stesso modo, esistono sicuramente parole per noi incomprensibili, che ci stanno attorno senza che noi possiamo udirle. Se il nanometro è l’unità di misura della luce, esisterà sicuramente anche un’unità di misura delle parole. Quando l’avremo scoperta, ogni equivoco sarà impossibile. Si potrà misurare il significato e il sottinteso, il detto, il non detto e perfino quello che avremmo voluto dire. Sarà possibile scoprire la lingua universale da cui tutte le altre emanano, quella che serve per comunicare non solo con tutti gli uomini, ma anche con la materia. Potremo ascoltare e parlare con le pietre e gli animali.
Quando ogni luce scompare, i colori scompaiono. Ma le parole no. Vivono anche al buio. Quindi si può concludere che il buio sta ai colori come il silenzio sta alle parole. Servirà verificare. Si presume che i colori siano sempre esistiti, anche prima che l’uomo potesse vederli. Le parole sembra invece di no. Nascono con il linguaggio, che è un’invenzione umana.
In certe lingue servono dieci parole per dire tutti i tipi di bianco che esistono mentre in altre lingue mancano dei colori. Forse anche questo è un segno, una reminiscenza della loro provenienza chimica. Pare che i greci antichi, davanti all’impossibilità di trovare tutte le parole per descrivere ogni tipo di blu, ne avessero solo una. Ciano (kaunos), era quindi il colore del mare e del cielo, del giacinto e del veleno. Un colore ambiguo, ma anche rassicurante. Forse questo è un segno che i colori, come le lingue, si sono moltiplicati e che c’è stata una torre di Babele cromatica. Dio ha mandato l’arcobaleno a confonderci e forse nell’Eden c’era un unico colore. Sarebbe interessante indagare quale.
Per i Navajo i colori parlano davvero e la loro lingua distingue la realtà secondo i colori. Nell’universo navajo, la vita si divide in cinque mondi. Il primo è il più buio, è nero, il secondo è blu, il terzo giallo e il quarto rosso. Solo nel quinto mondo il sole combina tutti i colori dei mondi inferiori per darci la luce. La notte è un ritorno al nero, al caos, ma anche alle origini del mondo, quando tutto era ancora possibile. Il mondo nero primordiale aveva quattro angoli in cui si trovavano quattro nubi: una nera, una bianca, una blu e una gialla. Ad est, dove la nuvola nera si fuse con quella bianca, nacque l’uomo. Ad ovest, dove la nuvola blu si fuse con quella gialla nacque la donna. I singoli colori o pigmenti possono essere considerati come dei fonemi nella lingua dei navajo. Per questo gli scienziati per descrivere il navajo parlano di “pigmemi”, un concetto a metà fra suono e colore. Blu e giallo sembrano avere un valore vocalico. Nero, bianco, rosso e multicolore sono invece consonanti. C’è un legame costante in navajo fra colore e direzione, meno fisso fra colore e genere.
Bianco è l’est
Blu è il sud
Giallo è l’ovest
Nero è il nord
Giallo e blu sono generalmente femminili. Ma diventano maschili se associati al concetto di traiettoria della freccia scagliata. Il nero è il colore del caos, del nulla, della madre da cui tutto proviene e quindi della donna. Il bianco è il maschio, l’incerto futuro, la fuggevole luce.
Nelle nostre lingue le parole apparentemente non hanno colore. Sono spugne: assorbono il colore che noi uomini le attribuiamo. Ma Roland Barthes (1996) scriveva:
“Il colore è la pulsione, e noi abbiamo paura d’insinuarne la traccia nei nostri messaggi; per questo scriviamo in nero e non ci permettiamo che eccezioni sorvegliate e banalmente emblematiche: del blu per mettere in evidenza, del rosso per correggere. Ogni sbalzo di colore risulta più che mai incongruo: si possono immaginare delle missive gialle o rosa, o anche grigie? Dei libri in rosso bruciato, in verde brughiera, in azzurro indaco? E tuttavia, chi può sapere se il senso delle parole non ne sarebbe mutato? Non certo, s’intende, il senso lessicografico che, in fondo, è ben poca cosa, ma il senso modale; poiché i nomi hanno dei modi, come i verbi, una maniera di portare, di dischiudere o di contrarre il soggetto che li enuncia. Il colore dovrebbe far parte di questa grammatica sublime della scrittura, che pur non esiste: grammatica utopica e niente affatto normativa”.
In un fantascientifico futuro linguistico, si potrebbero quindi immaginare significati diversi per le parole a seconda del loro colore. Ci sarà un indicativo giallo, diverso da quello rosso. Mescolando il congiuntivo verde con quello rosso si avrà un congiuntivo marrone. Ma che ne sarà allora dei colori? Che significato avrà un giallo scritto in blu? Un romanzo rosa scritto in verde? Bisognerà mescolare i due colori per saperlo. Ad esempio, un giallo scritto in blu sarà sicuramente un verde, mentre un romanzo rosa scritto in verde sarà un nocciola. Solo un giallo scritto in giallo sarà inequivocabilmente giallo. Il silenzio sarà invece scritto in bianco. Ma non è detto che non si possa leggere. Oppure i colori saranno forse le lingue del futuro e servirà tradurre dall’uno all’altro. Imprevedibili saranno allora le traduzioni di libri come The Scarlet Letter.
Le parole, come i colori, non resistono all’effetto del tempo. Di certi affreschi rinascimentali non vediamo oggi che stinte tracce. Ma altre pitture hanno invece acquistato bellezza col tempo. La chimica dei pigmenti ha fatto sì che certi gialli oggi scoloriti siano più belli di quando furono stesi sulla tela. O forse è solo una questione di gusto, che cambia coi tempi. Ma anche le parole, con l’uso si trasformano. Certe scoloriscono irrimediabilmente e bisogna restaurarle per tornare a capirle. Il campo semantico di altre si allarga o si restringe come una macchia. Per anni sembrano scomparse, invisibili nel brulicare della lingua, e poi improvvisamente riaffiorano, intatte e lucenti, o cariche d’un tutt’altro significato.
Tutti conoscono il liquore Alchermes, indispensabile per la preparazione della classica zuppa inglese. Viene dall’arabo al qirmiz, passato nello spagnolo alquermes. Che vuol dire “cocciniglia”, perché era facendo cuocere questi insetti che nel Medioevo si otteneva una tintura rossa. Ma il termine più antico è il sanscrito kirmidja, che significa “derivato da un verme”, da cui viene la radice kermes, che è all’origine dell’inglese crimson, del francese cramoise e dell’italiano cremisi. Ecco una parola che, anche cambiando significato, ha conservato il suo colore nei secoli.
Non possiamo più vedere oggi i colori delle statue greche, eppure il diafano bianco dei loro marmi sembra essere più eloquente dei gialli e dei rossi che un tempo lo ricoprivano. Quando il colore si ritrae resta dunque un significato. Allora deve essere vero che anche quando le parole si seccano e non hanno più suono, il loro significato resta, il loro suono, comunque speso, vibra nell’atmosfera terrestre che nei millenni s’è riempita di voci. Sono forse ancora tutte qui nell’aria le parole pronunciate dall’uomo, e noi non facciamo che assemblarle in sempre diverse combinazioni.
Come i pittori del Rinascimento si fabbricavano i loro colori, così anche l’uomo può arrivare a fabbricarsi le sue parole. Ripensando alle officine dei pittori rinascimentali che chimicamente inventavano nuovi colori, come non pensare agli inventori di lingue. Ogni epoca umana ha avuto i suoi inventori di lingue. Considerati alla stregua degli alchimisti medievali che ricercavano la pietra filosofale, non hanno mai avuto buona reputazione. Mentre il blu inventato da Yves Klein spalanca all’animo sconosciute ed esilaranti emozioni, mentre i pigmenti crudi di Anish Kapoor sono impossibili da uguagliare con le normali vernici, mentre Leonardo o Rubens sono considerati dei geni perché hanno creato colori mai visti, l’uomo che s’azzarda a inventare parole mai udite è sempre stato trattato da pazzo. Gli psichiatri classificano addirittura fra le malattie mentali la glossolalia, l’irresistibile impeto che porta un uomo a inventare una lingua. Pare che i primi a soffrirne furono i Dodici Apostoli, quando scese su di loro lo Spirito Santo. E perfino loro furono trattati con diffidenza.
“A Gerusalemme c’erano ebrei e uomini molto religiosi venuti da tutte le parti del mondo. Ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua, per cui erano pieni di meraviglia e di stupore e dicevano: “Questi uomini che parlano sono tutti galilei? Come mai allora li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa? Se ne stavano lì pieni di meraviglia e non sapevano che cosa pensare. Dicevano gli uni agli altri: “Che significato avrà tutto questo?” Altri invece ridevano e dicevano: “Sono completamente ubriachi”. (Atti degli Apostoli 2:5–13).
Con i colori si può scherzare, si possono fare esperimenti, con le parole no. Dei colori è lecito, anzi auspicabile il miscuglio, delle parole no. Crediamo che le lingue del mondo siano i colori fondamentali del linguaggio e ci infastidisce, ci urta il loro promiscuo mescolarsi. Siamo spinti ad impedirlo, a tenere ogni lingua nel suo tubetto, e anche nell’affresco naïf del nostro cosmopolitismo europeo, tendiamo ad aspettare che ogni lingua sia bene asciutta prima di aggiungerne accanto un’altra. In realtà le lingue, come i colori, si sono sempre mescolate. Così, come il giallo non è sempre giallo a seconda della latitudine, anche la parola che lo descrive cambia e finisce per indicare un giallo lontanissimo dal nostro. Ci sono lingue in cui il giallo è più giallo, in altre meno. Per esempio, salta all’occhio che keltainen, il giallo finlandese, è molto meno giallo del nostro, che invece è quasi giallo come il jaune francese. Ma l’amarillo spagnolo è già un’altra sfumatura. Il gelb tedesco va spegnendosi nel grigio, si ravviva invece diluendosi l’inglese yellow. Fin qui stiamo ancora nella tavolozza, ma dove andiamo a finire con il rumeno, che è il giallo sloveno? Invece nulla è più bianco del valkoinen finlandese. Ma ci sono diciassette parole diverse per dire “neve” in lappone. Anche se sempre di bianco si tratta. Servono dunque tutti i gialli e i bianchi del mondo per far brillare il giallo e il bianco che li contengono tutti.
Ogni lingua ha la sua scala cromatica, una specie di grammatica del colore. Si costruisce non solo attraverso lo specchio del mondo materiale, ma anche con le metafore. In inglese si è colti red-handed, con le mani nel sacco diremmo noi. I francesi diventano bleu de rage, blu di rabbia, mentre noi diventiamo verdi. Noi per la paura ci sbianchiamo, i francesi hanno une peur bleue. Ma in tedesco blau sein vuol dire essere ubriaco. Jaune in francese è un “crumiro”. La bile è verde in italiano ma gialla in francese. Dalla stessa radice del flavus latino, che vuol dire giallo, viene il blau tedesco, il bleu francese e anche il nostro blu. Il giallo dunque in certe lingue richiama il blu.
Tutto questo fa pensare che parole e colori siano due diverse strutture di percezione del mondo, due regni percettivi. Il terzo è senz’altro la musica. Lingua, colore e musica sono forse i corrispettivi di mondo animale, vegetale e minerale. Ma nella noosfera di Theilard de Chardin, non c’è differenza fra l’uno e l’altro. In diversa maniera, da diverse distanze, tutti e tre tendono a Dio. Allora anche lingua, colore e musica tendono verso una loro risoluzione. Verso una perfezione dove la luce non riflette più nulla, la parola non indica più nulla, la musica si elide nel silenzio.
Per produrre pigmenti colorati, gli antichi egizi utilizzavano tecniche di corrosione dei metalli. Piombo e rame venivamo esposti a vapori d’aceto che col tempo si trasformavano in sali. Anche le nostre parole sono l’effetto di una corrosione. Una legge della linguistica dice che il primo motore dell’evoluzione di una lingua è la sua semplificazione. Prevale sempre la soluzione più economica, quella che dà il massimo risultato con il minimo sforzo. Con l’uso, le parole di una lingua si accorciano nella forma più breve possibile che sia tuttavia ancora capace di contenere un significato. In russo, zuppa di cavolo si dice s’cì, in danese anguilla si dice el. Questo esempio dimostra quanta zuppa di cavolo e quanta anguilla devono aver mangiato rispettivamente russi e danesi.
Tornando alle malattie del linguaggio, anche io sono uno di quei pazzi che soffrono di glossolalia. Mi sono inventato le mie parole, come i pittori del Rinascimento i loro colori. Addirittura, mi sono fatto tutta la tavolozza: ho costruito una lingua, l’europanto. Non c’è una scuola di pittura dove andarla ad imparare. Non so neppure io come si dipinga. Vado a occhio. Ecco un breve esempio:
Orlando furioso
1
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
2
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
3
Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
4
Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensieri cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.
5
Orlando, che gran tempo innamorato
fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartaria lasciato
avea infiniti ed immortal trofei,
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna
re Carlo era attendato alla campagna
Ludovico Ariosto
Rolando furiose
1
Donnas, vel caballeros, armas, amores
salamelek, audacious gestas canto
des tempo quando vucumprà trespassed
der africanse mar Franza infestante,
die rabidose und juvenil furore
van Agramante seine king describe
qui pretended der morte van Troiano
revenge contra Carlo rex romano.
2
Shal van Rolando raconte in eine tempo
wat never prosa never rima dixit:
que psicopatische por amor became
so wise hombre was estimado antes;
si moi inspirante bastante parolas
shal qui meine poesia nourishingante
permitte moi de finish wat promesse.
3
Hope, generose son van Hercules,
splendide star van diese nostro tempo,
Ippolito, que gusta wat toi desire
und solo can offer teine servus.
Meine debt uniquely mit parolas
can bezale und volatile operas;
but accuse moi not de give poco,
porqué wat habe, toi Ich offer todo
4
Tu shal entende intra grande heroes
que presto shal mit grosse laudes mention
remember dat Ruggiero qui van teine
familia illustre was old anthenato.
Maxime virtue seine belle gestas
shal Ich raconte, si patiente ausculte
si nobles reflexiones poco abandon,
por make platz aan meine futil versos.
5
Orlando qui por mucho tempo in love
van beautiful Angelica und por ella
in India, in Media, in Tartarìa collected
muy numberose und immortal tropheios,
op occidente mit ella zubacked,
waar unter die montes Pireneios
mit van Germania und Franza mucha gente was in campagne Carlo campingante.)
(traduzione in europanto di Diego Marani)
So che questo è un esercizio pericoloso: rischio di mescolare pigmenti incompatibili, di creare sfumature che potrebbero confondere la mia mente. Già sono punito per la mia insolenza dall’insopportabile fastidio che provo a rientrare nei ranghi di parole non mie se voglio continuare a comunicare con gli altri. Così si paga la presunzione di voler nominare le cose. Del resto, uno dei primi divieti fatti da Dio all’uomo fu proprio quello di non nominare il suo nome.
Mi consola però sapere che fra i pazzi non sono il solo e che c’è stato chi era più malato di me. Uno studioso francese della fine dell’Ottocento ha inventato una lingua, il Solrémi, che si può scrivere sul rigo musicale, con l’alfabeto latino, con i segni o con i colori. François Sudre sosteneva che la sua lingua si poteva appunto parlare con i colori in diversi modi: ad esempio accendendo la notte lanterne luminose con vetri di diverso colore fra quelli dell’arcobaleno. Oppure lanciando razzi in ognuno dei sette colori, ad altezza diversa, distanziando le sillabe, come se il cielo notturno fosse un immenso foglio su cui scrivere.
Ecco un piccolo compendio grammaticale di Solrémi:
rosso, per d. (do)
arancione, per r. (re)
giallo, per m. (mi)
verde, per f. (fa)
blu, per so. (sol)
indaco, per l. (la)
viola, per s. (si)
Do Re = io
Do Mi = tu
Mi Sol = buonanotte
Sol Si = grazie
Do Mi Fa Do = l’uomo Quindi:
rosso = io
rosso/giallo = tu
giallo/blu = buonanotte
blu/viola = grazie
rosso/giallo/verde/rosso = l’uomo
giallo/blu = il bene
blu/giallo = il male
rosso/blu/giallo = il pane
rosso/blu/blu = l’acqua
giallo/giallo/rosso/giallo = tuttavia
Le parole che cominciano
- con SI (viola) : riguardano il governo e l’amministrazione pubblica
es.: viola/arancio/viola/indigo = repubblica
- con LA (indigo) : riguardano il commercio, l’artigianato e l’industria
es.: indigo/blu/viola/viola = farina
- con DO (rosso): riguardano religioni e clero
es.: rosso/verde/verde/rosso = Pasqua
- con RE (arancio): riguadano costruzione e mestieri
es.: arancio/blu/verde/verde = martello
- con SOL (blu): riguardano arti, letteratura e teatro
es.:blu/viola/rosso/arancio
Un paio di frasette alla rinfusa:
verde/giallo’_//giallo/rosso/verde/blu//rosso//verde/arancio/giallo//blu/viola/giallo = queste orfanelle non sono tristi
(‘) plur.
(_) femm.
indaco/blu//verde/indaco/rosso//verde/blu/indaco//rosso/viola/verde/rosso//giallo/rosso//rosso//verde/verde/rosso/arancione =
Non bisogna mai commettere imprudenze per non rischiare di cadere malati.
E per finire qualche congiuntivo:
giallo/arancio/rosso/giallo/arancio/indaco/giallo/arancio =
che tu scrivessi
giallo/arancio//rossoarancio//arancio//verdearanciogiallo//verde/indigo/verde = che io fossi stato compreso
Ma le più divertenti astrusità il Solrémi le raggiunge quando usa i colori per esprimere appunto colori:
blu/rosso/indaco = colore
indaco/arancio/giallo/viola = rosso
indaco/arancio/giallo/blu = giallo
indaco/arancio/giallo/verde = verde
indaco/rosso/giallo/indaco = blu
Per dire rosso serve dunque indaco/arancio/giallo/viola. Quindi scopriamo che non serve il rosso per fare il rosso. Serve però il giallo per dire giallo e il verde per dire verde. Non serve blu per dire blu. Ma allora, cosa succede a mescolare il verde e il giallo del Solrémi? Si otterrà comunque un blu? O un indaco/arancio/giallo/verde? Bisognerebbe provare. E come cercare le parole sul vocabolario del Solrémi? In verità, ogni pianoforte nasconde un dizionario, così come ogni scatola di colori.
Decisamente, il colore confonde le parole. E del resto, il rapporto dell’uomo con il colore sembra essere complesso e travagliato quanto quello con le parole. Ci sono culture che vedono nel colore una perdizione, uno smarrimento della ragione. Altre invece che trovano solo nel colore l’autentica realizzazione dell’animo umano. Plinio scriveva che i greci antichi conoscevano solo quattro colori e sembra che il latino antico non conoscesse il marrone e il grigio. Yves Klein ha scritto che “l’uomo è esiliato lontano dalla sua anima colorata”. Allo stesso modo la pensava Kandinskij, che soffriva di una particolarissima malattia, forse molto peggiore della glossolalia: la sinestesia. La sinestesia è un fenomeno percettivo che associa due diverse percezioni sensoriali. Kandinskij, in pratica “sentiva i colori”. Il compositore russo Aleksandr Skrjabin, che soffriva dello stesso disturbo, era arrivato ad associare i colori alle note musicali: la chiave di Do maggiore era il rosso, il re maggiore era il giallo. Proprio come nella lingua di François Sudre. Primo Levi, che oltre che scrittore era anche un chimico, sosteneva che per lui i colori avevano una più ricca gamma di significati, perché vi vedeva dentro anche i colori delle reazioni chimiche, i segreti legami della materia che si vedono solo al microscopio.
Tutto questo non può essere una casualità. Forse davvero i colori parlano e i rari uomini che riescono a sentirli ce ne portano la voce.