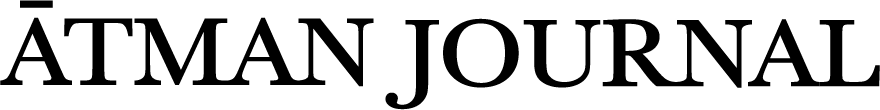L’elezione di Xi Jinping nel 2012 ha tracciato una nuova traiettoria di sviluppo e ascesa per la Repubblica Popolare Cinese. Nonostante ciò, in pochi avrebbero pensato che nel 2013 la Cina si sarebbe lanciata nella realizzazione del più ambizioso progetto infrastrutturale, geopolitico e geoeconomico mai tentato nel corso della storia: ben dodici volte più costoso, al netto dell’inflazione, rispetto al Piano Marshall lanciato dagli USA al termine della Seconda Guerra mondiale. L’ambizioso piano, denominato BRI (Belt and Road Initiative) o One Belt One Road mira a coinvolgere via terra e via mare più di 60 Nazioni appartenenti ad Africa, Asia, Europa e Sud America, con l’obiettivo finale di dar vita ad una rete di infrastrutture commerciali, economiche ed energetiche a livello globale.
Dopo l’annuncio, un gran numero di Paesi, africani e asiatici in primis, si sono dimostrati fortemente interessati a far parte del progetto e hanno accettato di buon grado i prestiti e gli investimenti arrivati dalla Cina. Quest’ultima nell’ultimo ventennio ha ripreso e integrato, alla luce del rapidissimo sviluppo economico nazionale, la strategia ideata da Mao nel campo della politica estera; una strategia volta fin dalla Conferenza di Bandung del 1955 a porsi come guida alternativa all’URSS per l’indipendenza e la crescita di quelle Nazioni definite “non allineate” nel contesto bipolare. Pechino fin dall’inizio del XXI secolo si è abilmente presentata come un soggetto differente rispetto agli Stati coloniali europei, non intenzionata a imporre regole in campo giuridico o economico. Impostando le relazioni bilaterali sulla base di una strategia “win-win” e utilizzando al meglio il proprio soft-power è riuscita in poco tempo ad attrarre a sé molti governi. L’Europa, Italia inclusa, è stata inizialmente disposta a collaborare con Pechino per sviluppare i collegamenti nell’ambito della BRI ma negli ultimi anni si è notata una brusca virata dovuta agli enormi timori che l’iniziativa cinese ha sollevato nei palazzi del potere in Occidente, soprattutto alla Casa Bianca.
Osservando la spregiudicatezza con la quale Pechino ha portato avanti i suoi progetti e timorosi della sua aggressività, gli analisti hanno iniziato ad approfondire le componenti strategiche e geopolitiche insite nella Belt and Road Initiative con l’obiettivo di capire se e come ad un’espansione commerciale ed economica seguirà una contestuale penetrazione militare.
Gli Stati Uniti hanno imparato la lezione dell’Ammiraglio Alfred T. Mahan[1]: è possibile mantenere il controllo dei flussi economici e commerciali e se necessario, isolare i propri avversari grazie al controllo degli oceani. Sarebbe irrealistico credere che la Cina, sebbene storicamente non sia una Nazione particolarmente improntata alla guerra, non decida di approfittare della BRI per aumentare le proprie capacità militari all’estero, soprattutto quella di pattugliamento delle linee marittime dove transitano le merci da e verso il Paese.
Già nel 2004, l’ex Presidente Hu Jintao per la prima volta parlò di una “nuova missione storica” e introdusse il concetto secondo cui la Cina avrebbe dovuto difendere i suoi interessi non solo sul continente ma anche oltremare. Otto anni dopo, il XVIII Congresso del Partito Comunista Cinese stabilì che la Cina dovesse diventare una “grande potenza navale”. La dirigenza cinese ha sottolineato la necessità di dotarsi di “punti di approdo strategici” necessari a difendere gli interessi cinesi e a proiettare la propria influenza politica e militare nelle “regioni influenti”[2].
Di fronte alle rinnovate ambizioni cinesi, nel 2004 la Booz Allen Hamilton, società di consulenza americana, coniò il concetto di “strategia del filo di perle” per descrivere la volontà cinese di dar vita ad una “collana” in grado di isolare l’India, proteggere gli approvvigionamenti energetici e commerciali e aumentare la presenza nell’Indo-Pacifico. Le perle più pregiate di questa collana vanno individuate nei quattro porti ad uso duale (civile e militare) di Gwadar, Doraleh, Hambantota e Kyaukphyu, rispettivamente in Pakistan, Gibuti, Sri Lanka e Myanmar, quattro Stati fortemente coinvolti nella BRI. I primi due hanno una valenza strategica alla luce della propria vicinanza al Medio Oriente, mentre gli ultimi svolgono un ruolo chiave nel settore dell’Indo-Pacifico.
Innanzitutto, il porto pakistano ricopre un ruolo fondamentale dal punto di vista economico in quanto costituisce il punto di arrivo del Corridoio Economico Cina-Pakistan e il punto di partenza dell’oleodotto che porterà nello Xinjiang il petrolio del Golfo Persico, consentendo a Pechino di evitare il turbolento Stretto di Malacca, attraverso cui passa l’80% del petrolio importato dalla Cina. Dal punto di vista militare la base di Gwadar rappresenta un asset strategico di primaria importanza in quanto situata vicino al Golfo Persico e allo Stretto di Hormuz, dal quale transita più del 20% dell’intera produzione mondiale di idrocarburi; inoltre, offre la possibilità di accerchiare il nemico indiano anche da Ovest. Sebbene il porto sia stato acquistato dalla Cina con lo scopo iniziale di utilizzarlo come scalo commerciale, le immagini satellitari sollevano dubbi su quale sarà la vera funzione della struttura; infatti, dal 2019 è possibile notare come nel territorio circostante al porto siano stati costruiti almeno tre compound e allestite misure di sicurezza inusuali per un semplice porto commerciale. Altri rapporti indicano invece la volontà cinese di costruire basi navali e aeree anche sulla penisola di Jiwani, a circa 50 km da Gwadar, mossa che avvicinerebbe ancora di più la Cina al Golfo Persico e soprattutto al porto di Chabahar, punto strategico per l’India in Iran.
La base più importante è senza dubbio quella di Doraleh, costruita tra il 2016 e il 2017 in Gibuti, piccolo e poverissimo Stato del Corno d’Africa ma situato in una posizione geografica altamente strategica. Il Paese, infatti, si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali “colli di bottiglia” mondiali che rappresenta il passaggio obbligatorio per l’accesso allo stretto di Suez, dal quale passa circa il 12% del commercio marittimo mondiale. In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato in cui la Cina ha assunto il ruolo di “fabbrica del mondo”, controllare un punto nevralgico per l’economia globale è di fondamentale importanza per la RPC.
La posizione occupata dal Paese unita alla sua estrema povertà ha reso Gibuti sempre di più uno Stato cuscinetto, una posizione che ha mantenuto sin dalla sua creazione nel 1860. La Francia, ex dominatrice coloniale, ha costituito fino al 2001 la principale potenza impegnata nello Stato. Successivamente agli attacchi terroristici dell’11 settembre e sulla scia della Guerra Globale al Terroreportata avanti da George W. Bush, gli Stati Uniti hanno costruito Camp Lemmonier, unica base americana permanente nel continente africano. Questa struttura consente a Washington di avere un vantaggio rispetto ai suoi competitori e di controllare una regione martoriata da guerre e dalla proliferazione di movimenti jihadisti come gli Al- Shabaab in Somalia. Nel corso degli anni altri Stati come Italia, Giappone e Arabia Saudita hanno costruito strutture logistiche e militari nel territorio gibutino ma la maggior preoccupazione di Washington è ovviamente destata dalle manovre cinesi nell’area. A tal proposito, Il Comandante del U.S. Africa Command, Stephen Townsend, ha avvertito che l’acquisizione di questa base consentirà a Pechino di proiettare il proprio potere nella regione e rappresenta una delle perle che formano la collana di basi con cui la RPC mira a controllare una vasta area triangolare di Oceano Indiano tra Gibuti, Pakistan e Sri Lanka.

Fonte immagine: IstockPhoto
La base di Doraleh è presentata da Pechino come una struttura logistica necessaria a condurre le missioni antipirateria nel Golfo di Aden e per offrire riparo ai cargo cinesi che operano sulle rotte intercontinentali ma rappresenta in realtà la prima base militare dell’Esercito di Liberazione Popolare (ELP) al di fuori dei confini cinesi. Questa base ospita le forze speciali e i marines che addestrano le forze locali, possiede eliporti e piste per gli aerei e, dopo i lavori di ampliamento che dovrebbero terminare nel 2026, potrà ospitare le portaerei e oltre 10.000 soldati, circa il doppio di quelli stanziati dagli USA nel Paese.
Hambantota è un altro punto di enorme interesse strategico per la Repubblica Popolare Cinese sia economicamente sia militarmente. La posizione nell’estremo Sud dello Sri Lanka gli conferisce la definizione di “faro dell’Oceano Indiano” e consentirà alla Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione di sorvegliare le affollatissime linee di comunicazione e di transito commerciale. Allo stesso tempo, la posizione geografica costituisce una spina nel fianco per l’India che risulta sostanzialmente accerchiata e con gravi dilemmi securitari. Teoricamente, nel contratto stipulato con la Cina non era previsto alcun tipo di utilizzo militare del porto; teoricamente, dato che a causa del mancato pagamento del debito nei confronti delle banche cinesi, nel 2017 la Cina ha requisito il porto e il suo retroterra per 99 anni e, potendo disporne a proprio piacimento, ci si aspetta che in futuro possa offrire un ulteriore punto di stazionamento per le navi militari e commerciali cinesi[3].
Il porto di Kyaukphyu è un’altra perla che la Cina ha ottenuto e che ha in mente di utilizzare in maniera duplice. Anche in questo caso, la scelta del luogo non è stata casuale, dato che si affaccia sul Golfo del Bengala e permetterà alla Cina di vigilare la linea marittima che conduce allo Stretto di Malacca, da cui passano più di 16 milioni di barili di petrolio al giorno, rendendo questo corridoio il secondo più importante per il trasporto petrolifero dopo Hormuz. Il secondo motivo che ha portato la Cina a investire nella zona è che proprio da Kyaukphyu parte l’oleodotto che termina nella provincia cinese dello Yunnan e che è funzionale a risolvere, almeno in parte, l’annoso “Dilemma di Malacca”[4]. Sembra difficile che la Marina cinese possa arrivare nel breve periodo a stazionare nel porto, anche a causa della Costituzione del Myanmar che impedisce la permanenza di truppe straniere in territorio nazionale; nonostante ciò, vari analisti credono che in futuro l’opacità dei contratti stipulati oltre all’effettivo strapotere cinese possa comportare un utilizzo del porto anche a scopo militare.
Alla luce dell’evidente competizione tra due superpotenze come gli Stati Uniti e la Cina, la BRI assume sempre più importanza non solo per le proprie componenti economiche e commerciali ma anche dal punto di vista militare e strategico. Per queste ragioni negli ultimi anni i paesi occidentali, così come anche altre nazioni asiatiche, hanno messo sotto la lente di ingrandimento le azioni compiute dalla Cina nell’ambito della BRI. Ci si aspetta che nel medio periodo Pechino possa acquisire ulteriori basi e punti di approdo sufficienti a proiettare in maniera decisa la forza militare nel settore dell’Indo-Pacifico; se così fosse entreremmo in un’autentica nuova era in cui il dominio oceanico a stelle e strisce potrà essere seriamente sfidato dalla Repubblica Popolare Cinese.
[1] Alfred T. Mahan, “L’influenza del potere marittimo sulla storia”, 1890.
[2] Shou Xiaosong, “Science of Military Strategy.” Beijing: Military Science Publishing, as cited in Kardon, Testimony Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission.”
[3] Daniel R. Russel e Blake H. Berger, Weaponizing the Belt and Road Initiative, “Asia Society Policy Institute”, 09/2020 pp. 24–26.
[4] Lo stretto di Malacca si affaccia sulle acque territoriali di Malesia, Indonesia e Singapore e le sue strettoie e i nascondigli naturali offrono condizioni favorevoli per l’attività piratesca, oltre che la possibilità per i Paesi citati di turbare i commerci. Da questo punto transita circal’80 % del petrolio importato dalla Cina e per questo motivo si parla di “dilemma” nell’ambito dell’approvvigionamento energetico.