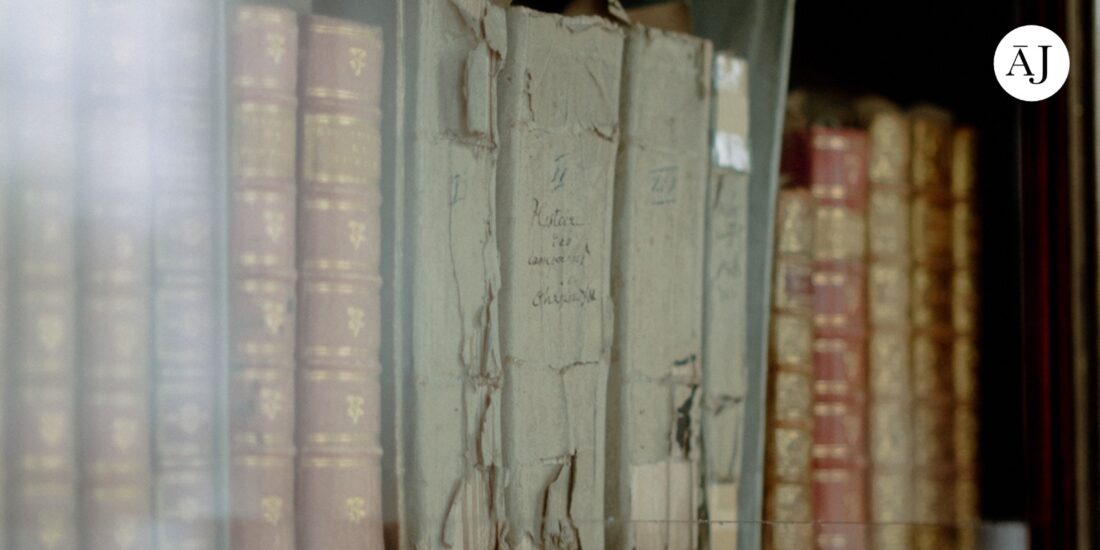La lunga vita di Marianna Ucrìa, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nel 1990 e vincitore del Premio Campiello, rappresenta uno dei vertici narrativi di Dacia Maraini. Scrittrice, poetessa, drammaturga e voce imprescindibile della letteratura italiana contemporanea, Maraini ha dedicato gran parte della sua produzione alla riflessione sulla condizione femminile, intrecciando memoria personale, indagine storica e impegno civile.
Figlia di una famiglia colta e cosmopolita, trascorse l’infanzia in Giappone, dove fu internata in un campo di concentramento in seguito al rifiuto dei genitori di sostenere la Repubblica di Salò. In età adulta, ha partecipato attivamente alle battaglie femministe degli anni Settanta. Non sorprende, dunque, che nel ritratto di Marianna Ucrìa si rifletta la sua attenzione costante verso figure di donne che resistono all’oppressione sociale.
Ambientato nella Sicilia del XVIII secolo, La lunga vita di Marianna Ucrìa ricostruisce un mondo di contrasti: lo splendore barocco delle ville nobiliari e la miseria estrema dei contadini, il potere assoluto dell’aristocrazia e il giogo dell’Inquisizione, la rigida morale patriarcale e la vita privata segnata da violenza e sopruso. Marianna Ucrìa, ispirata a un’antenata di Maraini — l’autrice stessa ne racconta brevemente in Bagheria (1993) — nasce in una famiglia nobile, e, all’età di tredici anni, viene costretta a sposare lo zio, l’uomo che l’aveva violentata da bambina rendendola sordomuta. La sua vita si snoda tra gravidanze imposte, lutti, incontri inattesi, viaggi e amicizie che la aprono a nuovi orizzonti intellettuali e culturali.
Il mutismo di Marianna, causato dal trauma, è una metafora potente: il silenzio a cui la società relega le donne. Anziché rassegnarsi, la protagonista trasforma però la sua condizione in una forza: “Il silenzio si era impadronito di lei come una malattia o forse una vocazione” (Maraini 1990, 53). Marianna comunica attraverso la scrittura, divora libri — “Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé” (Maraini 1990, 67) — sviluppa un pensiero critico e coltiva la curiosità verso il mondo. La sua vita è segnata da una consapevolezza lucida: «Gli occhi hanno l’ambizione di possedere le forme complete nella loro integrità» (1990, 123), frase che non è solo un’osservazione sensoriale, ma il manifesto della sua sete di conoscenza e della sua volontà di comprendere il mondo oltre le apparenze.
La vita di Marianna Ucrìa si configura come un percorso di crescita interiore e di affrancamento intellettuale in un mondo profondamente ingiusto e gerarchico, dominato da un rigido patriarcato. La sua condizione di sordomuta, che inizialmente la relega ai margini della comunicazione e della vita sociale, diventa paradossalmente il punto di partenza per uno sguardo più acuto e penetrante sulla realtà. Marianna sviluppa una visione del mondo che non si accontenta delle verità imposte dalla cultura dominante: attraverso lo studio, la lettura, la scrittura e l’osservazione attenta, costruisce una propria coscienza critica, unica e rivoluzionaria per il contesto in cui vive. La sua diversità, lontana dall’isolarla, diventa il motore di una comprensione più profonda delle dinamiche sociali. A differenza delle donne del suo ceto, Marianna non si limita a compiti decorativi: gestisce beni, osserva con attenzione le ingiustizie sociali, interviene per aiutare gli oppressi. In un passaggio rivelatore, di fronte alla miseria contadina, pensa: «Forse la giustizia non è di questo mondo, ma il mio cuore non lo accetta» (Maraini 1990,156). Il suo sguardo non è indifferente alle sofferenze altrui e in questa frase si condensa tutta la tensione morale che guida le sue scelte: se il mondo si fonda sull’ingiustizia, Marianna non si rassegna. È una donna che, pur nei limiti storici imposti dalla sua epoca, compie piccoli ma significativi atti di resistenza, opponendo alla rassegnazione l’empatia, alla passività l’azione, al silenzio imposto la forza del pensiero.
Maraini, attraverso questa figura, costruisce un personaggio che si fa emblema della possibilità di trasformazione: Marianna non è solo testimone del cambiamento, ma ne diventa agente, incarnando una forma di emancipazione silenziosa ma tenace e andando a rappresentare dunque un modello di femminista ante litteram: rifiuta la definizione di donna come proprietà maschile, critica i matrimoni imposti, cerca relazioni basate sulla libertà, difende le altre donne, valorizza l’istruzione come strumento di emancipazione (Chemello 2005). In un’epoca in cui il valore femminile era misurato dalla capacità di generare figli maschi, la sua priorità è la dignità della persona, non il rispetto delle convenzioni sociali. La sua capacità di resistere è sintetizzata in una frase che suona come un manifesto: «Non c’è silenzio che possa impedire a un pensiero di nascere» (Maraini 1990, 192).
La figura di Marianna Ucrìa si può accostare ad un’altra protagonista del panorama letterario contemporaneo, che, pur immersa in un contesto storico e culturale profondamente oppressivo, riesce a esprimere una forma di resistenza, non attraverso atti clamorosi o rivoluzioni esterne, ma attraverso una ribellione intima, silenziosa e interiore: si tratta di Cecilia, figura centrale di Stabat Mater di Tiziano Scarpa (2008). Cecilia, orfana cresciuta nell’Ospedale della Pietà nella Venezia settecentesca, vive un’esistenza di isolamento e privazione. L’istituto in cui cresce la forma per diventare musicista, ma le nega affetto, verità e identità; lei non conosce l’origine della propria esistenza e sente su di sé un vuoto enorme: la mancanza della madre. La sua ribellione prende corpo attraverso due strumenti: la musica, che diventa per lei linguaggio dell’anima, e la scrittura, che esercita in segreto, di notte, attraverso lettere immaginarie rivolte a quella madre assente. Cecilia non si ribella apertamente, ma coltiva dentro di sé un’urgenza di espressione che sfugge al controllo dell’istituzione e la rende, di fatto, libera nel pensiero. Marianna e Cecilia sono, dunque, due donne private della parola: entrambe, però, riescono a ‘parlare’ attraverso forme diverse: la scrittura, l’arte, la riflessione. Non gridano la loro protesta, ma la lasciano emergere nei gesti quotidiani, nelle domande che si pongono, nella ricerca ostinata di un senso. In un’epoca in cui le donne erano spesso ridotte a oggetti muti, esse si affermano come soggetti pensanti, capaci di introspezione e di resistenza.
Il personaggio di Marianna Ucrìa dialoga idealmente con le donne del femminismo novecentesco, soprattutto con quelle che, negli anni Sessanta e Settanta, rivendicarono il diritto all’istruzione, alla libera scelta del partner, all’autodeterminazione del corpo. Come loro, Marianna comprende che la libertà passa attraverso la consapevolezza culturale e la capacità di sottrarsi a ruoli predefiniti. La sua figura sembra per certi versi anticipare alcune istanze centrali del secondo femminismo — quello che, con opere come Il secondo sesso del 1949 di Simone de Beauvoir e Sputiamo su Hegel del 1981 di Carla Lonzi, rifiutava l’idea della donna come ‘altro’ rispetto all’uomo e denunciava il patriarcato come struttura sociale e culturale radicata. L’opera di De Beauvoir, una delle più influenti nella storia del pensiero femminista, rappresenta una svolta fondamentale nel dibattito sulla condizione della donna. L’autrice affronta la questione della “differenza sessuale” non come una realtà naturale e immutabile, ma come una costruzione culturale e storica che ha posto la donna in una posizione subalterna rispetto all’uomo e ritiene che che la liberazione della donna può avvenire solo attraverso l’autodeterminazione, la presa di coscienza del suo stato di oppressione e la lotta contro le strutture sociali che la mantengono in quella condizione. De Beauvoir esplora inoltre come la società abbia socializzato le donne per interiorizzare questo ruolo di ‘altro’ e come la maternità, la sessualità e la famiglia siano stati strumenti di dominazione e oppressione (Rossi-Doria, 2008).
Il percorso di Marianna Ucrìa nel romanzo di Maraini rientra nelle dinamiche descritte da de Beauvoir: la protagonista, come molte donne nella storia, è vissuta come ‘l’altro’ nella sua società e nella sua famiglia, ma la sua evoluzione verso la consapevolezza di sé è un percorso di rottura con l’immagine stereotipata della donna passiva e sottomessa. Il suo rifiuto del matrimonio imposto e la ricerca di uno spazio personale di pensiero e azione richiamano anche le pratiche del movimento di liberazione delle donne in Italia, nato nel 1970, che sosteneva l’autocoscienza come strumento per ‘prendere parola’ sul proprio corpo e la propria vita. Come nel caso di Marianna Ucrìa, che alla fine del romanzo acquisisce una consapevolezza radicale della sua condizione e dei limiti imposti dal patriarcato, anche Lonzi, con la sua opera, invita le donne a non cercare il riconoscimento all’interno di una cultura che le ha sempre marginalizzate, ma a creare nuove forme di pensiero e nuove pratiche di vita che siano libere dalle dinamiche patriarcali.
Tanto nel pensiero di Simone de Beauvoir quanto in quello di Carla Lonzi, si trova un forte rifiuto della condizione di subalternità della donna, che è storicamente costruita e istituzionalizzata da una cultura patriarcale che la vede come la parte mancante rispetto all’uomo (Rossi-Doria, 2008). Marianna Ucrìa è consapevole di essere stata relegata a una posizione subordinata nella società. La sua emancipazione, però, non passa attraverso l’accettazione delle strutture sociali che la opprimono, ma attraverso un lento e doloroso processo di riscoperta della sua voce, della sua libertà e del suo pensiero autonomo, allo stesso modo in cui Lonzi non accetta il pensiero filosofico che la riduce a un ‘oggetto’ da decifrare, ma rivendica la sua soggettività. Marianna, attraverso il suo percorso di consapevolezza, sembra prefigurare il tipo di autonomia femminile che entrambe queste autrici auspicano: un’autonomia che non cerca conferme nel sistema culturale dominante, ma che, al contrario, rifiuta quel sistema e cerca di costruire nuove forme di vita, di pensiero e di relazione.
Eppure, mentre il femminismo novecentesco si è espresso con manifestazioni pubbliche, collettivi e campagne legislative — per il divorzio, per la legge sull’aborto, per la parità salariale — la battaglia di Marianna è privata, silenziosa, condotta nello spazio ristretto delle sue relazioni e della sua casa. Tuttavia, questa dimensione domestica non ne sminuisce la portata rivoluzionaria: nella Sicilia del XVIII secolo, leggere testi stranieri, amministrare beni, proteggere una serva da un’ingiusta condanna, o semplicemente rifiutare di sottomettersi passivamente, equivaleva a sovvertire l’ordine costituito. In questo senso, Marianna si pone come una ‘sorella lontana’ delle femministe novecentesche: il suo linguaggio non è quello dello slogan, ma quello del gesto privato, e la sua arma non è la piazza, ma la pagina scritta. Entrambe, però, condividono la stessa aspirazione: liberare la donna dalla gabbia del ruolo imposto.
Tuttavia, è importante ricordare che Marianna Ucrìa non era una donna del popolo, ma apparteneva all’aristocrazia siciliana. La sua posizione sociale le garantiva privilegi materiali, un certo accesso alla cultura e un’autonomia gestionale impensabile per molte altre donne del suo tempo. Ed è proprio da questa posizione di apparente potere che si svela la contraddizione: Marianna, pur nobile, era pur sempre una donna in un sistema patriarcale in cui il genere annullava ogni altro titolo. Le sue battaglie, per quanto ‘private’, erano tutt’altro che invisibili: si confrontavano direttamente con il potere maschile, incarnato nel marito – che è anche suo zio – e nella logica familiare che aveva normalizzato il suo stupro infantile, travestendolo da dovere matrimoniale. Il marito, figura emblematica della violenza istituzionalizzata, non è solo l’uomo che la possiede contro la sua volontà, ma rappresenta anche la continuità di un ordine sociale in cui le donne sono oggetti da scambiare per preservare il patrimonio.
Marianna non denuncia apertamente, non può farlo nel contesto in cui vive, ma elabora lentamente un rifiuto interiore che si traduce in scelte concrete: si isola emotivamente, coltiva il sapere, educa i figli a un pensiero più libero, e, dopo la morte del marito, assume il controllo del patrimonio familiare. Il suo silenzio, spesso letto come condanna alla passività, diventa invece lo spazio di una resistenza elaborata e profonda, una forma di sopravvivenza e affermazione individuale in un mondo che la voleva sottomessa.
In definitiva, la figura di Marianna Ucrìa dimostra che la lotta per l’autodeterminazione femminile può nascere anche tra le mura di un palazzo nobiliare, e che la consapevolezza non è privilegio della modernità: è un seme che può germogliare ovunque ci sia ingiustizia, purché qualcuno trovi il coraggio – o il dolore – per ascoltarla. Marianna diventa così un archetipo che attraversa i secoli: la donna che, pur imprigionata in una struttura sociale oppressiva, riesce a trasformare i vincoli in opportunità di resistenza e crescita personale. La sua voce non si sente, ma si legge e si avverte: «Gli occhi parlano e nessuno può impedirlo» (Maraini 1990, 121). In un’altra riflessione, Marianna sembra in quale modo anticipare l’idea di sorellanza: «Fra donne ci si riconosce, anche senza parole» (Maraini 1990, 188).
Con La lunga vita di Marianna Ucrìa, Dacia Maraini non racconta soltanto la storia di una donna lontana dai dettami del suo secolo, ma mostra come la consapevolezza di sé possa essere il primo passo verso il cambiamento. Uno degli aspetti più potenti del romanzo, infatti, è proprio l’evoluzione interiore di Marianna; la sua consapevolezza di sé non nasce in un solo momento, ma è il frutto di un percorso lungo e tortuoso, in cui la protagonista riflette continuamente sulla propria condizione e sulle ingiustizie che subisce. Il silenzio imposto dalla sua sordità diventa un canale privilegiato di conoscenza, un luogo in cui Marianna, lontano dai rumori e dai diktat sociali, può finalmente ascoltare la sua voce interiore, spesso ignorata dal mondo. È proprio questa consapevolezza di sé che le permetterà, nel corso del romanzo, di sfidare le convenzioni e di prendere decisioni che la portano a un graduale e doloroso riscatto.
Marianna non ha voce, eppure il suo silenzio è più eloquente di mille proclami: un atto di resistenza che la avvicina alle battaglie femministe di ogni epoca, ricordandoci che l’emancipazione comincia sempre da uno sguardo critico sul proprio mondo e da una volontà incrollabile di non piegarsi.
Fotografia di Andrea Camiolo
Bibliografia
De Beauvoir, S. [1949] 1961. Il secondo sesso (Le Deuxième Sexe, 1949), trad. it. Cantini R., Andreose M., Il Saggiatore, Milano.
Chemello, A. 2005. Marianna Ucrìa: il silenzio come resistenza, in Le eroine della narrativa contemporanea, a cura di F. Guarnieri, pp. 89–104, Donzelli, Roma.
Lonzi, C.1970. Sputiamo su Hegel e altri scritti, Scritti di Rivolta Femminile, Milano
Magazzeni, L. 2001. Scritture di donne tra memoria e finzione, in Quaderni di italianistica, vol. 22, n. 2, 117–130.
Maraini, D. 1990. La lunga vita di Marianna Ucrìa, Rizzoli, Milano.
Maraini, D. 1993. Bagheria, Rizzoli, Milano.
Mondo, L. 1990, 16 ottobre. “La Sicilia della Maraini: una nobildonna contro il suo destino”, La Stampa.
Rossi-Doria A. 2008. “Il movimento delle donne in Italia. Esperienze, relazioni e pratiche politiche (1968–1978)”, in Italia contemporanea, n. 253, Viella, Roma.
Scarpa, T. 2008, Stabat Mater, Collana Supercoralli, Einaudi, Torino.