Qualcuno li chiama GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Sono i giganti digitali che dominano l’economia e hanno una grande presenza nella nostra vita di tutti i giorni. È corretto chiamarli giganti? Utilizzando il metro della capitalizzazione di mercato, ovvero di quanto valgono le loro azioni prese tutte assieme, i cinque GAFAM si trovano tutti nei primi sette posti della classifica delle società quotate in borsa più grandi del mondo.

“The 100 largest companies in the world by market capitalization in 2023 (in billion U.S. dollars)”
Cosa significa essere la società più grande del mondo? Mentre scrivo questa nota, la capitalizzazione di mercato delle prime due, Microsoft e Apple, è salita a circa tremila miliardi di dollari per ciascuna. La cifra è molto maggiore del prodotto interno lordo dell’Italia, che nel 2022 superava di poco i duemila miliardi. Dico così, per avere una pietra di paragone, consapevole che il confronto corretto andrebbe fatto non con il valore di borsa ma con il fatturato annuale. Ma qualche analogia dobbiamo pur trovarla, perché i giganti digitali sono così grandi che sfuggono alla nostra comprensione. Facciamo un altro esempio. Se avessi un’ora per ogni dollaro investito nelle azioni della Microsoft e le usassi per andare indietro nel tempo, arriverei a 114 milioni di anni fa ovvero al Cretacico inferiore, quando comparivano sulla terra le api e i primi mammiferi antenati dell’ornitorinco odierno.
È opinione comune che il gigantismo digitale sia un problema di difficile soluzione per le autorità pubbliche che cercano di governarlo a tutela e beneficio di tutti noi. Ma credo che esista un problema parallelo altrettanto urgente; che la dismisura di queste imprese sia anche una sfida per l’immaginazione. Credo che non siamo ancora in grado di comprendere il potere e l’influenza dei GAFAM e della manciata di altre imprese che con il passare degli anni hanno assunto dimensioni quasi altrettanto smisurate. Non saprei come rispondere se mi chiedessero cosa abbiamo davvero in mente quando le chiamiamo ‘giganti’. Pensiamo al Grande Gigante Gentile di Roald Dahl oppure ai ciclopi, abili inventori e costruttori delle mura di Micene ma anche esseri rozzi e mangiatori di uomini?
L’immaginazione non vacilla solamente di fronte al gigantismo. Quando la tecnologia digitale ci è arrivata in casa, nei primi anni ottanta, aveva già i tratti del mistero e del prodigio. Primo Levi comprese la sfida che il suo computer appena acquistato gli lanciava nel 1984, quando ne scrisse sulla terza pagina de La Stampa. A quanto ne sappiamo, il computer in questione era probabilmente un Macintosh, il primo personal della Apple di larga diffusione. Levi confessa di accettare in parte il mistero del suo nuovo elaboratore, rinunciando a capire come funziona prima di poter mettere le dita sulla tastiera, e utilizza per descriverlo espressioni che si associano al soprannaturale. Il suo elaboratore, dice, è «capace di molti miracoli che ancora non conosco e che mi intrigano».
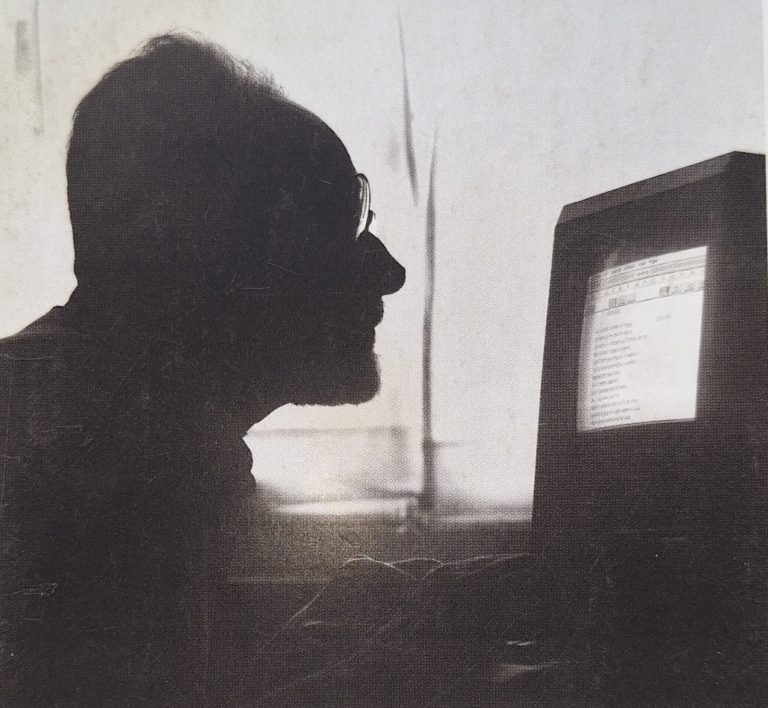
Immagine ed elaborazione dell’autore, tratta dalla copertina di Primo Levi, Conversazioni e interviste, Einaudi, 1997
L’analogia magica più evidente riguarda il leggendario Golem. Levi nota che l’elaboratore ha «la bocca storta, socchiusa in una smorfia meccanica» e che resta «una esanime scatola metallica» finché in quella bocca non si inserisce un dischetto. Si chiede a questo punto se i suoi creatori si fossero ispirati al Golem. «Si narra che secoli addietro un rabbino-mago avesse costruito un automa di argilla, di forza erculea e di obbedienza cieca, affinché difendesse gli ebrei di Praga dai pogrom; ma esso rimaneva inerte, inanimato, finchè il suo autore non gli infilava in bocca un rotolo di pergamena su cui era scritto un versetto della Torà» (tutte le citazioni sono tratte da “Personal Golem”, La Stampa, 15 novembre 1984, p. 3). Come si vede, da quarant’anni dobbiamo ricorrere a figure fantastiche frutto dell’immaginazione, come i giganti e il Golem, per venire a patti con una tecnologia e uno sviluppo industriale ai quali ci avviciniamo «pien[i] di angoscia: l’angoscia dell’ignoto» (ibid.).
L’ultimo sviluppo in ordine di tempo, poi, ci appare come un’autentica diavoleria. A novembre del 2022 è comparso in rete il primo sistema generativo, basato su un cosiddetto Large Language Model (LLM), che tutti possiamo utilizzare senza pagare esplicitamente il biglietto. Per capire l’aspetto soprannaturale che si avverte in questa innovazione basta leggere gli innumerevoli commenti sulla stampa o ascoltare cosa ne dice la gente. Il Golem in fondo era un bruto capace solo di dar botte, almeno nelle intenzioni del suo artefice. Sbaragliava i nemici degli ebrei di Praga come farebbe una fiera ammaestrata, che so, una ferocissima tigre. L’intelligenza artificiale generativa, invece, ci batte sul terreno della conoscenza.
E qui mi trovo costretto a chiedere aiuto io stesso a un personaggio della letteratura per venire a capo dell’intelligenza artificiale generativa. Come Pinocchio, a cui Geppetto insegna come si sta al mondo prima di farlo uscire di casa, questi sistemi devono essere addestrati prima di entrare in funzione. Li hanno chiamati ‘pappagalli stocastici’ (cliccare qui per leggere l’articolo che ha coniato l’espressione), ma quando li usiamo ci danno l’impressione di essere tutt’altro che pappagalli, bensì sistemi autonomi, capaci di trovare da soli la strada per imparare cose nuove e rispondere in modo originale alle domande che gli rivolgiamo. Questo è ciò che sa fare OS One, il sistema operativo immaginato nel film Her, in cui il protagonista si innamora della voce che trova nel telefonino dopo averlo installato, convinto che sia come una donna in carne ed ossa.
Locandina di Her
Queste facoltà dei sistemi generativi – vere, false, presunte, temute o millantate – odorano tutte di zolfo. Certo, anche Pinocchio si mette a parlare per magia quando è ancora un tronco da sbozzare, ma da quel momento in poi si comporta come un piccolo sbandato che però desidera diventare un bambino come tutti gli altri. Invece il mistero dei sistemi generativi che forse ci preoccupa di più è proprio il loro destino ultimo. Non sappiamo cosa impareranno a fare man mano che diventano sempre più potenti e perfezionati. Per esempio, i sistemi generativi di oggi non sono capaci di cogliere il nocciolo di un testo o di una conversazione – ciò che i linguisti chiamano ‘pertinenza’ – e io credo che attualmente questo sia il loro limite più serio. Non so dire se questa facoltà potrà emergere un giorno con il crescere della complessità. Sarebbe curioso che emergesse davvero, perché pare che il genere umano abbia seguito un percorso simile. Gli studiosi dibattono da tempo l’ipotesi che l’intelligenza umana non sia altro che un comportamento emerso nel corso dell’evoluzione grazie alla crescente complessità della mente. Mentre aspettiamo di vedere cosa farà l’intelligenza artificiale del futuro, è lecito chiedersi fin d’ora che cosa ci farà, perché se per disgrazia le cose si mettono male non siamo sicuri di poterla fermare. Non abbiamo più il rotolo di pergamena che, sfilato dalla bocca, spegneva il Golem della leggenda.
L’angoscia dell’ignoto di cui scriveva Primo Levi si proietta quindi nel futuro, ma neppure il presente ci lascia del tutto tranquilli. Riprendo cocciutamente il parametro già utilizzato sopra della capitalizzazione di mercato. Da ottobre 2022 alla metà di marzo del 2024, il valore di cento principali imprese attive nei mercati in cui si suddivide il settore dell’intelligenza artificiale è cresciuto di ottomila miliardi di dollari. Parliamo di quattro volte il PIL italiano, e torna una passeggera vertigine da gigantismo. Occorre precisare che non tutto l’aumento è imputabile direttamente all’esplosione della nuova tecnologia, perché le borse hanno registrato un rialzo generale in questo lasso di tempo, ma la sua entità è comunque ragguardevole. Un secondo fenomeno da osservare con attenzione è che il valore complessivo del settore si sta concentrando sempre di più nelle mani di poche imprese. Da anni si osserva che l’economia digitale tende alla concentrazione in misura maggiore rispetto all’economia nel suo complesso e questo per una serie di motivi strutturali. Ebbene, l’andamento qui sembra ancora più accentuato e crescono in modo esasperato le disuguaglianze fra le imprese del settore. Chi potrà mai raggiungere e sfidare quelle che si trovano in vetta se la montagna diventa sempre più alta? Per finire, c’è la questione del rapporto fra queste tecnologie e il lavoro. Molti temono che l’intelligenza artificiale sia una minaccia per l’occupazione (rimando a questo approfondimento del settimanale The Economist per tutte queste considerazioni). Non so se il timore sia fondato, probabilmente non lo è, ma ciò che conta per il nostro ragionamento è che sia presente in larghe fasce della pubblica opinione.
Claude Monet, Charing Cross Bridge, brouillard sur la Tamise
La nebbia nella quale è immersa l’economia digitale e le inquietudini che suscita la nostra incapacità di osservarne con precisione i contorni derivano da molti altri fattori oltre a quelli toccati finora. C’è la manipolazione di massa della pubblica opinione, c’è il rischio di frammentazione del tessuto sociale, ci sono le bufale che distorcono la formazione del consenso e lo stesso processo democratico. Tutti questi temi vengono discussi quotidianamente sugli organi di stampa di qualità. Per concludere questa nota, vorrei aggiungere un fattore, direi, più sottile. Il mistero e l’inquietudine che circondano il mondo digitale derivano anche dal fatto che è per sua natura un mondo immateriale.
Ho già scritto di questo fatto qui su Ātman, nella seconda puntata della serie Compagna dell’impero intitolata “Botteghe oscure”. Possiamo rileggerne un brano: «In questi 25 anni sono nate e hanno conquistato quote smisurate di mercato imprese come Facebook, TikTok e Twitter che hanno una natura puramente semiotica. [Botteghe oscure] finora ha parlato [di] imprese che fanno polenta, borse in pelle, ‘spritz’, dentifrici e pannoloni per anziani. I social media invece si occupano solo di segni. Sono imprese che acquisiscono, trasformano, immagazzinano e distribuiscono parole, immagini, messaggi audio, video e poco altro.»
Allora parlavo dei social media e dei loro algoritmi che sono stati progettati fin dall’inizio per iniettare costantemente piccole dosi di dopamina nel corpo di miliardi di persone e generare dipendenza. Ma l’osservazione si può estendere a tutti i GAFAM e agli altri giganti digitali. Non credo che sia mai successo nella nostra storia che l’economia e la società fossero dominate in misura così importante da imprese le cui attività non si concentrano su ciò che viene dalla terra, né sulla produzione di beni materiali e nemmeno sui servizi tradizionali come banche, scuole e ospedali. Le attività delle imprese digitali hanno a che fare quasi completamente con le parole e gli altri segni, che sono entità immateriali.
Uno scorcio di Decentraland
L’economia dei mondi virtuali, dei metaversi e del gaming è forse l’esempio più chiaro del grado di inconsistenza del mondo digitale. Usando le criptovalute più diffuse o quelle create dalle stesse piattaforme si può regalare un paio di orecchini all’avatar seduta sulla panchina di un parco, oppure si può acquistare un lotto di terreno che dà sullo stesso parco magari per tirarci su un fabbricato da offrire sul mercato sempre all’interno del mondo virtuale. Le possibilità sono infinite e non occorre moltiplicare gli esempi. Ciò che mi interessa mostrare sono le scatole cinesi nelle quali a) un trasferimento elettronico che fai dalla tua banca online acquista b) una criptovaluta ancora più immateriale che in seguito spendi, poniamo, su Decentraland per acquistare c) un lotto di terreno digitale che offri d) nella sezione land del markeplace della piattaforma. A ogni passo diventa un ricordo sempre più lontano il mondo dove per distrazione urtiamo il tavolo della cucina e si versa il vino sulla tovaglia.
Eppure tutto comincia con gli euro perfettamente reali che escono dal conto e prosegue con le ore perfettamente reali che si passano dentro Decentraland per regalare gli orecchini e comprare il lotto sul parco. Quindi perché arrendersi all’immaterialità del mondo digitale come se il discorso finisse lì. Forse abbiamo bisogno di un cannocchiale per vedere meglio, perché ho la sensazione che qualcosa ancora sfugga a questa nota rispetto ai mondi virtuali, allo stupefacente spettacolo prodotto dall’intelligenza artificiale generativa e ai giganti digitali. Vediamo se l’arte della parola può darci ancora una mano. Una grande poetessa americana, Marianne Moore, ha scritto che nella poesia si possono trovare «giardini immaginari con dentro rospi veri» («imaginary gardens with real toads in them». “Poetry”, in Others for 1919; An Anthology of the New Verse, a cura di Alfred Kreymborg, N.L. Brown, 1920, pp. 131–132. Traduzione dell’autore). Chissà se anche il mondo digitale – immateriale, nebbioso, pappagallesco, magico e smisurato – si regge su questo paradosso. Chissà se è anche per questo motivo che lo troviamo, tutti, irresistibile.



